5.3. IL “LIBRETTO ROSSO” DI GRAMSCI
«Chi dalla tribuna parlamentare o in un comizio, si vale della sua autorità, del suo prestigio, per far credere alle masse che oggi la soluzione della crisi possa essere all'infuori dell'abbattimento dello Stato borghese, non si merita titolo diverso da quello di traditore».(da Illusioni, L'Ordine Nuovo, 8 agosto 1921)
L'invito è a leggere in formato integrale le opere di Gramsci, così complesse e approfondite che per qualcuno sarà un delitto realizzare un piccolo “Libretto Rosso” dell'autore. Chiaramente anche questo, come gli altri, che troverete ancora nell'opera, vanno visti come degli spunti per un'ulteriore approfondimento personale, costituendo però a nostro avviso una adeguata introduzione grazie ad alcune riflessioni e temi troppo spesso dimenticati o distorti, come abbiamo già avuto modo di vedere. Di seguito quindi alcuni estratti delle sue opere tratte dai Quaderni dal Carcere e dagli scritti apparsi soprattutto sull'Ordine Nuovo.
Sulle accuse di essere nostalgici e “vecchi”:
«Ci accusano di essere vecchi. In certi momenti, sensibili come siamo ai rimproveri, alle facce irosamente beffarde dei nostri avversari, sentiamo anche noi come una diminuzione di noi stessi, ci sembra davvero di essere decrepiti, di non riuscire a far sgorgare dalle nostre labbra la parola definitiva, la parola che dia forza ai nostri organi. Ma una breve riflessione scaccia questo pessimismo. Ci sentiamo vecchi perché il destino perverso ci ha fatti nascere in età vecchia. È l'aria che respiriamo, sono gli istituti che ci reggono, sono gli uomini coi quali siamo in lotta, che sono vecchi».(da Vecchiezze, Avanti!, ediz. piemontese,
13 luglio 1916, sotto la rubrica Sotto la Mole)
Su Mussolini:
«Divinizzato, dichiarato infallibile, preconizzato organizzatore e ispiratore di un rinato Impero romano […] conosciamo quel viso: conosciamo quel roteare degli occhi nelle orbite che nel passato dovevano, con la loro ferocia meccanica, far venire i vermi alla borghesia e oggi al proletariato. Conosciamo quel pugno sempre chiuso alla minaccia […] Mussolini […] è il tipo concentrato del piccolo-borghese italiano, rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale da vari secoli di dominazione degli stranieri e dei preti: non poteva essere il capo del proletariato; divenne il dittatore della borghesia, che ama le facce feroci quando ridiventa borbonica».
Sugli uomini “provvidenziali”:
«A un certo punto dello sviluppo storico, le classi si staccano dai loro partiti tradizionali, cioè i partiti tradizionali in quella data forma organizzativa, con quei determinati uomini che li costituiscono o li dirigono, non rappresentano più la loro classe o frazione di classe. È questa la crisi più delicata e pericolosa, perché offre il campo agli uomini provvidenziali o carismatici. Come si forma questa situazione di contrasto tra rappresentati e rappresentanti, che dal terreno delle organizzazioni private (partiti o sindacati) non può non riflettersi nello Stato, rafforzando in modo formidabile il potere della burocrazia (in senso lato: militare e civile)? In ogni paese il processo è diverso, sebbene il contenuto sia lo stesso. La crisi è pericolosa quando essa si diffonde in tutti i partiti, in tutte le classi, quando cioè non avviene, in forma acceleratissima, il passaggio delle truppe di uno o vari partiti in un partito che meglio riassume gli interessi generali. Questo ultimo è un fenomeno organico [e normale], anche se il suo ritmo di avveramento sia rapidissimo in confronto ai periodi normali: rappresenta la fusione di una classe sotto una sola direzione per risolvere un problema dominante ed esistenziale. Quando la crisi non trova questa soluzione organica, ma quella dell’uomo provvidenziale, significa che esiste un equilibrio statico, che nessuna classe, né la conservatrice né la progressista hanno la forza di vincere, ma anche la classe conservatrice ha bisogno di un padrone». (dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 4 [XIII], voce 69, Sui partiti)
Sul fascismo: [Al giudice, che prima della condanna a 20 anni e 4 mesi di carcere gli aveva chiesto che cosa avrebbero fatto i comunisti se l'Italia fosse entrata in guerra]:
«Voi fascisti porterete l'Italia alla rovina, e a noi comunisti spetterà salvarla!»
«Il fascismo si è presentato come l’anti-partito, ha aperto le porte a tutti i candidati, ha dato modo a una moltitudine incomposta di coprire con una vernice di idealità politiche vaghe e nebulose lo straripare selvaggio delle passioni, degli odi, dei desideri. Il fascismo è divenuto così un fatto di costume, si è identificato con la psicologia antisociale di alcuni strati del popolo italiano».Dall'unico discorso parlamentare pronunciato alla Camera:
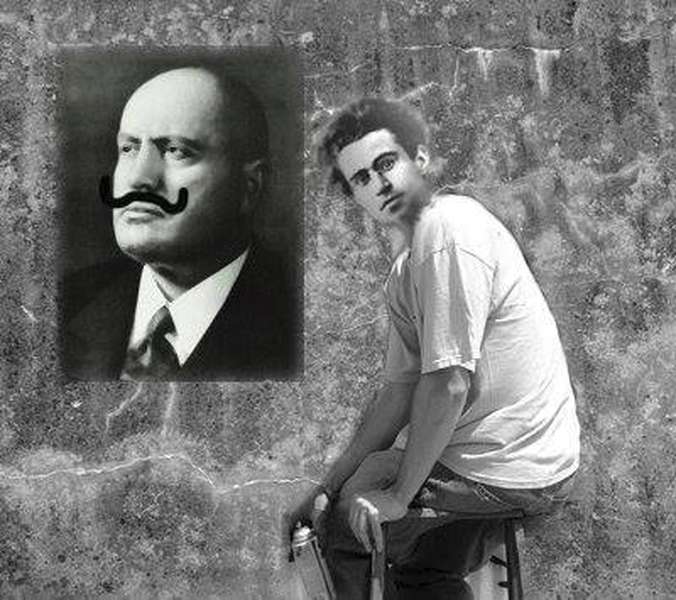
«-Gramsci: La rivoluzione fascista è solo la sostituzione di un personale amministrativo ad un altro.
-Mussolini: Di una classe ad un’altra, com’è avvenuto in Russia, come avviene normalmente in tutte le rivoluzioni!
-Gramsci: È rivoluzione solo quella che si basa su una nuova classe. E il fascismo non si basa su nessuna classe che non sia già al potere. […]
-Mussolini: Il Partito comunista ha meno iscritti del partito fascista!
-Gramsci: Ma rappresenta la classe operaia!
-Farinacci: La tradisce, non la rappresenta!
-Gramsci: Il vostro è consenso ottenuto col bastone».
Ancora sul fascismo, ma anche sullo Stato borghese e la violenza del Capitale:
«Lo Stato borghese deve farsi sempre più reazionario, deve sempre più direttamente e violentemente intervenire nella lotta delle classi, per reprimere i tentativi che il proletariato fa nella via della sua emancipazione. Questa «reazione» non è solo italiana: essa è un fenomeno internazionale, perché il capitalismo non solo in Italia ma in tutto il mondo è divenuto incapace a dominare le forze produttive. Il fenomeno del «fascismo» non è solo italiano, così come non è solo italiano il formarsi del partito comunista. Il «fascismo» è la fase preparatoria della restaurazione dello Stato, cioè di un rincrudimento della reazione capitalistica, di un inasprimento della lotta capitalistica contro le esigenze più vitali della classe proletaria. Il fascismo è l'illegalità della violenza capitalistica: la restaurazione dello Stato è la legalizzazione di questa violenza».(da Cos'è la reazione, Avanti!, 20 novembre 1920)Su come si debba combattere il fascismo e rifiutare il liberalismo, armando gli operai:

«L'operaio, il contadino, il quale odia il fascismo che da anni l'opprime, crede dunque necessario per abbatterlo di allearsi alla borghesia liberale, di appoggiare coloro che nel passato, quand'erano al potere, hanno sostenuto e armato il fascismo contro gli operai e i contadini quali ancora pochi mesi or sono formavano un solo blocco con il fascismo e ne condividevano pienamente tutta la responsabilità dei delitti? Ed è così che si pone il problema della liquidazione del fascismo? No! La liquidazione del fascismo deve essere la liquidazione della borghesia che lo ha creato. […] Per vincere il fascismo è necessaria l'azione della massa del proletariato industriale e dei contadini; la lotta di classe con tutte le conseguenze. Il proletariato potrà e dovrà senza dubbio utilizzare nella sua lotta contro il fascismo le opposizioni e le lotte che si sono sviluppate nel seno della borghesia e della piccola borghesia, ma senza l'azione diretta il fascismo non potrà mai essere abbattuto. Porre così il problema era, nel tempo stesso, porre chiaramente la questione della successione al fascismo. Vinto il fascismo dall'azione delle masse operaie e contadine, il liberalismo non ha nulla a che fare nella successione; questo diritto appartiene al governo degli operai e dei contadini che solo sarà capace ed avrà la sincera volontà di disarmare la milizia fascista, armando la classe operaia ed i contadini. Nell'ora attuale si tratta di ben altro che di ritorno alla Costituzione, di democrazia e di liberalismo. Sono queste ultime delle parole melliflue che la borghesia cerca di far ingoiare ai lavoratori della città e della campagna per evitare che la crisi acquisti il suo vero carattere, cioè di rivincita degli operai e dei contadini contro il fascismo che li ha soppressi e contro il liberalismo che li ha ingannati e che, ancor mesi or sono, collaboravano o cercavano di collaborare […] con Mussolini. […] Un governo di classe di operai e di contadini, che non si preoccupa né della Costituzione, né dei sacri principi del liberalismo, ma che è deciso a vincere definitivamente il fascismo, a disarmarlo e a difendere contro tutti gli sfruttatori gli interessi dei lavoratori della città e della campagna; ecco la sola forza giovane capace di liquidare un passato di oppressione, di sfruttamento e di delitti e di dare un avvenire di vera libertà per tutti coloro che lavorano. […] Il compito essenziale del nostro Partito consiste nel far penetrare fra gli operai e i contadini queste idee fondamentali: Soltanto la lotta di classe delle masse operaie e contadine vincerà il fascismo. Soltanto un governo di operai e di contadini è capace di liquidare il fascismo e di sopprimerne le cause. Soltanto l'armamento degli operai e dei contadini potrà disarmare la milizia fascista. Quando queste verità essenziali saranno penetrate nello spirito della massa operaia e contadina per mezzo della nostra instancabile propaganda, i lavoratori delle officine e dei campi, a qualunque partito appartengano, comprenderanno la necessità di costituire i Comitati operai e contadini per la difesa dei loro interessi di classe e per la lotta contro il fascismo. Essi comprenderanno che questi sono gli strumenti necessari della lotta rivoluzionaria e della loro volontà di sostituire il governo degli assassini con un governo degli operai e dei contadini. Nel momento in cui si chiude il Congresso liberale che cerca ancora una volta d'ingannare il popolo lavoratore, da un capo all'altro dell'Italia, gli operai ed i contadini rispondano alle sue chiacchiere sonore e vuote: Né fascismo né liberalismo: soviettismo!»(da Né fascismo né liberalismo: soviettismo!, L'Unità, 7 ottobre 1924)

Su Karl Marx:
«Siamo noi marxisti? Esistono marxisti? Buaggine, tu sola sei immortale. […] Il vaniloquio e il bizantinismo sono retaggio immarcescibile degli uomini. Marx non ha scritto una dottrinetta, non è un messia che abbia lasciato una filza di parabole gravide di imperativi categorici, di norme indiscutibili, assolute, fuori delle categorie di tempo e di spazio. Unico imperativo categorico, unica norma: “Proletari di tutto il mondo unitevi”. Il dovere dell'organizzazione, la propaganda del dovere di organizzarsi e associarsi, dovrebbe dunque essere discriminante tra marxisti e non marxisti. Troppo poco e troppo: chi non sarebbe marxista? Eppure così è: tutti sono marxisti, un po', inconsapevolmente. Marx è stato grande, la sua azione è stata feconda, non perché abbia inventato dal nulla, non perché abbia estratto dalla sua fantasia una visione originale della storia, ma, perché il frammentario, l'incompiuto l'immaturo è in lui diventato maturità, sistema, consapevolezza. La consapevolezza sua personale può diventare di tutti, è già diventata di molti: per questo fatto egli non è solo uno studioso, è un uomo d'azione; è grande e fecondo nell'azione come nel pensiero, i suoi libri hanno trasformato il mondo, così come hanno trasformato il pensiero. Marx significa ingresso dell'intelligenza nella storia dell'umanità, regno della consapevolezza. La sua opera cade proprio nello stesso periodo in cui si svolge la grande battaglia tra Tomaso Carlyle ed Erberto Spencer sulla funzione dell'uomo nella storia. Carlyle: l'eroe, la grande individualità, mistica sintesi di una comunione spirituale, che conduce i destini dell'umanità verso un approdo sconosciuto, evanescente nel chimerico paese della perfezione e della santità. Spencer: la natura, l'evoluzione, astrazione meccanica e inanimata. L'uomo: atomo di un organismo naturale, che obbedisce a una legge astratta come tale, ma che diventa concreta, storicamente, negli individui: l'utile immediato. Marx si pianta nella storia con la solida quadratura di un gigante: non è un mistico né un metafisico positivista; è uno storico, è un interprete dei documenti del passato, di tutti i documenti, non solo di una parte di essi. Era questo il difetto intrinseco delle storie, delle ricerche sugli avvenimenti umani: esaminare e tener conto solo di una parte dei documenti. E questa parte veniva scelta non dalla volontà storica, ma dal pregiudizio partigiano, tale anche se inconsapevole e in buona fede. Le ricerche avevano come fine non la verità, l'esattezza, la ricreazione integrale della vita del passato, ma il rilievo di una particolare attività, il mettere in valore una tesi aprioristica. La storia era solo dominio delle idee. L'uomo era considerato come spirito, come coscienza pura. Due conseguenze erronee derivavano da questa concezione: le idee messe in valore erano spesso solamente arbitrarie, fittizie. I fatti cui si dava importanza erano aneddotica, non storia. Se storia fu scritta, nel senso reale della parola, si dovette ad intuizione geniale di singoli individui, non ad attività scientifica sistematica e consapevole.
Con Marx la storia continua ad essere dominio delle idee, dello spirito, dell'attività cosciente degli individui singoli od associati. Ma le idee, lo spirito, si sustanziano, perdono la loro arbitrarietà, non sono più fittizie astrazioni religiose o sociologiche. La sostanza loro è nell'economia, nell'attività pratica, nei sistemi e nei rapporti di produzione e di scambio. La storia come avvenimento è pura attività pratica (economica e morale). Un'idea si realizza non in quanto logicamente coerente alla verità pura, all'umanità pura (che esiste solo come programma, come fine etico generale degli uomini), ma in quanto trova nella realtà economica la sua giustificazione, lo strumento per affermarsi. Per conoscere con esattezza quali sono i fini storici di un paese, di una società, di un aggruppamento importa prima di tutto conoscere quali sono i sistemi e i rapporti di produzione e di scambio di quel paese, di quella società. Senza questa conoscenza si potranno compilare monografie parziali, dissertazioni utili per la storia della cultura, si coglieranno riflessi secondari, conseguenze lontane, non si farà però storia, l'attività pratica non sarà enucleata in tutta la sua solida compattezza. Gli idoli crollano dal loro altare, le divinità vedono dileguarsi le nubi d'incenso odoroso. L'uomo acquista coscienza della realtà obiettiva, si impadronisce del segreto che fa giocare il succedersi reale degli avvenimenti. L'uomo conosce se stesso, sa quanto può valere la sua individuale volontà, e come essa possa essere resa potente in quanto, ubbidendo, disciplinandosi alla necessità, finisce col dominare la necessità stessa, identificandola col proprio fine. Chi conosce se stesso? Non l'uomo in genere, ma quello che subisce il giogo della necessità. La ricerca della sostanza storica, il fissarla nel sistema e nei rapporti di produzione e di scambio, fa scoprire come la società degli uomini sia scissa in due classi. La classe che detiene lo strumento di produzione conosce già necessariamente se stessa, ha la coscienza, sia pur confusa e frammentaria, della sua potenza e della sua missione. Ha dei fini individuali e li realizza attraverso la sua organizzazione, freddamente, obiettivamente, senza preoccuparsi se la sua strada è lastricata di corpi estenuati dalla fame, o dei cadaveri dei campi di battaglia. La sistemazione della reale causalità storica acquista valore di rivelazione per l'altra classe, diventa principio d'ordine per lo sterminato gregge senza pastore. Il gregge acquista consapevolezza di sé, del compito che attualmente deve svolgere perché l'altra classe si affermi, acquista coscienza che i suoi fini individuali rimarranno puro arbitrio, pura parola, velleità vuota ed enfatica finché non avrà gli strumenti, finché velleità non sarà diventata volontà. Volontarismo? La parola non significa nulla, o viene usata nel significato di arbitrio. Volontà, marxisticamente, significa consapevolezza del fine, che a sua volta significa nozione esatta della propria potenza e dei mezzi per esprimerla nell'azione. Significa pertanto in primo luogo distinzione, individuazione della classe, vita politica indipendente da quella dell'altra classe, organizzazione compatta e disciplinata ai fini propri specifici, senza deviazioni e tentennamenti. Significa impulso rettilineo verso il fine massimo, senza scampagnate sui verdi prati della cordiale fratellanza, inteneriti dalle verdi erbette e dalle morbide dichiarazioni di stima e d'amore. Ma è inutile l'avverbio “marxisticamente”, e anzi esso può dare luogo ad equivoci e ad inondazioni fatue e parolaie. Marxisti, marxisticamente... aggettivo e avverbio logori come monete passate per troppe mani. Carlo Marx è per noi maestro di vita spirituale e morale, non pastore armato di vincastro. È lo stimolatore delle pigrizie mentali, è il risvegliatore delle energie buone che dormicchiano e devono destarsi per la buona battaglia. È un esempio di lavoro intenso e tenace per raggiungere la chiara onestà delle idee, la solida cultura necessaria per non parlare a vuoto, di astrattezze. È blocco monolitico di umanità sapiente e pensante, che non si guarda la lingua per parlare, non si mette la mano sul cuore per sentire, ma costruisce sillogismi ferrati che avvolgono la realtà nella sua essenza, e la dominano, che penetrano nei cervelli, fanno crollare le sedimentazioni di pregiudizio e di idea fissa, irrobustiscono il carattere morale. Carlo Marx non è per noi il fantolino che vagisce in culla o l'uomo barbuto che spaventa i sacrestani. Non è nessuno degli episodi aneddotici della sua biografia, nessun gesto brillante o grossolano della sua esteriore animalità umana. È un vasto e sereno cervello pensante, è un momento individuale della ricerca affannosa secolare che l'umanità compie per acquistare coscienza del suo essere e del suo divenire, per cogliere il ritmo misterioso della storia e far dileguare il mistero, per essere più forte nel pensare e operare. È una parte necessaria ed integrante del nostro spirito, che non sarebbe quello che è se egli non avesse vissuto, non avesse pensato, non avesse fatto scoccare scintille di luce dall'urto delle sue passioni e delle sue idee, delle sue miserie e dei suoi ideali. Glorificando Carlo Marx […], il proletariato internazionale glorifica se stesso, la sua forza cosciente, il dinamismo della sua aggressività conquistatrice che va scalzando il dominio del privilegio, e si prepara alla lotta finale che coronerà tutti gli sforzi e tutti i sacrifizi». (da Il nostro Marx, Il Grido del Popolo, 4 maggio 1918)

Sul Partito Comunista:
«Il Partito comunista è lo strumento e la forma storica del processo di intima liberazione per cui l'operaio da esecutore diviene iniziatore, da massa diviene capo e guida, da braccio diviene cervello e volontà; nella formazione del Partito comunista è dato cogliere il germe della libertà che avrà il suo sviluppo e la sua piena espansione dopo che lo Stato operaio avrà organizzato le condizioni materiali necessarie. Il Partito comunista, anche come mera organizzazione si è rivelato forma particolare della rivoluzione proletaria. Nessuna rivoluzione del passato ha conosciuto i partiti; essi sono nati dopo la rivoluzione borghese e si sono decomposti nel terreno della democrazia parlamentare. Anche in questo campo si è verificata l'idea marxista che il capitalismo crea forze che poi non riesce a dominare. I partiti democratici servivano a indicare uomini politici di valore e a farli trionfare nella concorrenza politica; oggi gli uomini di governo sono imposti dalle banche, dai grandi giornali, dalle associazioni industriali; i partiti si sono decomposti in una molteplicità di cricche personali. Il Partito comunista, sorgendo dalle ceneri dei partiti socialisti, ripudia le sue origini democratiche e parlamentari e rivela i suoi caratteri essenziali che sono originali nella storia: la rivoluzione russa è la rivoluzione compiuta dagli uomini organizzati nel Partito comunista, che nel partito si sono plasmati una personalità nuova, hanno acquistato nuovi sentimenti, hanno realizzato una vita morale che tende a divenire coscienza universale e fine per tutti gli uomini. […] I comunisti […] devono giungere fino alle ultime conclusioni del loro atteggiamento e della loro azione: salvare la compagine primordiale (ricostruendola) del partito della classe operaia, dare al proletariato italiano il Partito comunista che sia capace di organizzare lo Stato operaio e le condizioni per l'avvento della società comunista».(da Il Partito Comunista, L'Ordine Nuovo, 9 ottobre 1920)
Su quale debba essere il rapporto tra partito e sindacato:
«Dunque i sindacati devono essere subordinati al partito? Porre così la quistione sarebbe errato. La quistione deve essere impostata così: ogni membro del partito, qualsiasi posizione o carica occupi, è sempre un membro del partito ed è subordinato alla sua direzione. Non ci può essere subordinazione tra sindacato e partito, se il sindacato ha spontaneamente scelto come suo dirigente un membro del partito: significa che il sindacato accetta [liberamente] le direttive del partito e quindi ne accetta liberamente (anzi ne desidera) il controllo sui suoi funzionari».(dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 3 [XX], voce 42, Passato e Presente)
Sul nesso tra disciplina e libertà:
«Associarsi a un movimento vuol dire assumersi una parte della responsabilità degli avvenimenti che si preparano, diventare di questi avvenimenti stessi gli artefici diretti. Un giovane che si iscrive al movimento giovanile socialista compie un atto di indipendenza e di liberazione. Disciplinarsi è rendersi indipendenti e liberi. L'acqua è acqua pura e libera quando scorre fra le due rive di un ruscello o di un fiume, non quando è sparsa caoticamente sul suolo, o rarefatta si libra nell'atmosfera. Chi non segue una disciplina politica è appunto materia allo stato gassoso, o materia bruttata da elementi estranei: pertanto inutile e dannosa. La disciplina politica fa precipitare queste lordure, e dà allo spirito il suo metallo migliore, alla vita uno scopo, senza del quale la vita non varrebbe la pena di essere vissuta. Ogni giovane proletario che sente quanto sia pesante il fardello della sua schiavitù di classe, deve compiere l'atto iniziale della sua liberazione, iscrivendosi al Fascio giovanile socialista più vicino a casa sua».Sull'impossibilità di costruire il socialismo con il 50%+1, in evidente polemica contro i riformisti elettoralisti, liberal-democratici e gli attendisti (e in prospettiva non vi si può non leggere una critica alla degenerazione del PCI e in generale verso ogni velleità di costruire il socialismo a partire dalla democrazia liberale borghese):(da Disciplina e libertà, La Città Futura, 11 febbraio 1917)

«Accelerare l'avvenire. Questo è il bisogno più sentito nella massa socialista. Ma cos'è l'avvenire? Esiste esso come qualcosa di veramente concreto? L'avvenire non è che un prospettare nel futuro la volontà dell'oggi come già avente modificato l'ambiente sociale. Pertanto accelerare l'avvenire significa due cose. Essere riusciti a far estendere questa volontà a un numero tale di uomini quanto si presume sia necessaria per far diventare fruttuosa la volontà stessa. E questo sarebbe un progresso quantitativo. Oppure: essere riusciti a far diventare questa volontà talmente intensa nella minoranza attuale, che sia possibile l'equazione: 1=1.000.000. E questo sarebbe un progresso qualitativo. Arroventare la propria anima e farne sprizzare miriadi di scintille. […] Aspettare di essere diventati la metà più uno è il programma delle anime pavide che aspettano il socialismo da un decreto regio controfirmato da due ministri».(da Margini, La Città Futura, 11 febbraio 1917)
Sulla necessità di boicottare la stampa borghese:
«l'operaio deve negare recisamente qualsiasi solidarietà col giornale borghese. Egli dovrebbe ricordarsi sempre, sempre, sempre, che il giornale borghese (qualunque sia la sua tinta) è uno strumento di lotta mosso da idee e da interessi che sono in contrasto coi suoi. Tutto ciò che stampa è costantemente influenzato da un'idea: servire la classe dominante, che si traduce ineluttabilmente in un fatto: combattere la classe lavoratrice. E difatti, dalla prima all'ultima riga, il giornale borghese sente e rivela questa preoccupazione. Ma il bello, cioè il brutto, sta in ciò: che invece di domandare quattrini alla classe borghese per essere sostenuto nell'opera di difesa spietata in suo favore, il giornale borghese riesce a farsi pagare... dalla stessa classe lavoratrice che egli combatte sempre. E la classe lavoratrice paga, puntualmente, generosamente. Centinaia di migliaia di operai, danno regolarmente ogni giorno il loro soldino al giornale borghese, concorrendo così a creare la sua potenza. Perché? Se lo domandate al primo operaio che vedete nel tram o per la via con un foglio borghese spiegato dinanzi, voi vi sentite rispondere: “Perché ho bisogno di sapere cosa c'è di nuovo”. E non gli passa neanche per la mente che le notizie e gli ingredienti coi quali sono cucinate possono essere esposti con un'arte che diriga il suo pensiero e influisca sul suo spirito in un determinato senso. […] Tutti i giorni poi, capita a questo stesso operaio di poter constatare personalmente che i giornali borghesi raccontano i fatti anche più semplici in modo di favorire la classe borghese e la politica borghese a danno della politica e della classe proletaria. Scoppia uno sciopero? Per il giornale borghese gli operai hanno sempre torto. Avviene una dimostrazione? I dimostranti, sol perché siano operai, sono sempre dei turbolenti, dei faziosi, dei teppisti. Il governo emana una legge? È sempre buona, utile e giusta, anche se è... viceversa. Si svolge una lotta elettorale, politica od amministrativa? I candidati e i programmi migliori sono sempre quelli dei partiti borghesi. E non parliamo di tutti i fatti che il giornale borghese o tace, o travisa, o falsifica, per ingannare, illudere, e mantenere nell'ignoranza il pubblico dei lavoratori. Malgrado ciò, l'acquiescenza colpevole dell'operaio verso il giornale borghese è senza limiti. Bisogna reagire contro di essa e richiamare l'operaio all'esatta valutazione della realtà. Bisogna dire e ripetere che quel soldino buttato là distrattamente nella mano dello strillone è un proiettile consegnato al giornale borghese che lo scaglierà poi, al momento opportuno, contro la massa operaia. Se gli operai si persuadessero di questa elementarissima verità, imparerebbero a boicottare la stampa borghese con quella stessa compattezza e disciplina con cui la borghesia boicotta i giornali degli operai, cioè la stampa socialista. Non date aiuti di danaro alla stampa borghese che è vostra avversaria: ecco quale deve essere il nostro grido di guerra in questo momento che è caratterizzato dalla campagna per gli abbonamenti fatta da tutti i giornali borghesi. Boicottateli, boicottateli, boicottateli!» (da I giornali e gli operai, Avanti!, ediz. piemontese, 22 dicembre 1916)

Contro ogni concezione stereotipata del socialismo che viene giudicato impossibile perché presupporrebbe un uomo altruista, solidale, che non esisterebbe più, occorre ricordare questa affermazione di Gramsci che chiarisce bene il messaggio che occorra diffondere: gli interessi individuali di tutti si possono soddisfare al meglio solo nel socialismo, che permette a tutti di migliorare le proprie condizioni di vita. Deleterio è quindi ragionare in maniera moralistica o antropologica volendo rendere l'uomo una creatura altruista che non tenga conto delle proprie esigenze. Questa visione è più consona all'ideologia del cristianesimo piuttosto che del marxismo, il quale invece fonda la lotta di classe sulla ricerca di un miglioramento collettivo e universale delle condizioni materiali. Gramsci lo spiega così:
«Il progresso non consiste per lo più che nella partecipazione di un sempre maggior numero di individui a un bene. L'egoismo è il collettivismo degli appetiti e dei bisogni di un singolo: il collettivismo è l'egoismo di tutti i proletari del mondo. I proletari non sono certo altruisti nel significato che a questa parola danno gli umanitari frolli. Ma l'egoismo del proletariato è nobilitato dalla coscienza che il proletariato ha di non poterlo totalmente appagare senza che lo abbiano appagato nello stesso tempo tutti gli altri individui della sua classe. E perciò l'egoismo proletario crea immediatamente la solidarietà di classe». (da Margini, La Città Futura, 11 febbraio 1917)
Sul fatto che la libertà non passi per l'arricchimento individuale:
«La società contemporanea: una fiera rumorosa di uomini in delirio; nel centro della fiera una giostra che rotea turbinosamente, fulmineamente. Ognuno dei presenti vuol saltare in groppa a un lucente e ben bardato cavallino, a una sirena dai languidi occhi; vuole adagiarsi nei morbidi cuscini di una carrozzella. È un precipitarsi disordinato e caotico della folla in tumulto, è un osceno acrobatismo di arti scimmieschi. Diecimila cadono riversi, dopo essersi fiaccate le membra, uno per diecimila passa, si aderge su questi corpi innumeri, spicca il salto giusto, e trasvola nel turbine infernale. Tu vuoi partecipare alla gara. Hai probabilità, anche tu, di fortuna. Arrivare significa diventar ricco, essere signore della vita, conquistare la propria libertà. Ecco: la libertà. Fermiamoci. La ricchezza non è un fine, certamente; se diventa fine si chiama avidità (avarizia). È mezzo per un fine: la libertà. Un soldo che possiedi, è un soldo di libertà a tua disposizione, è un soldo di libera scelta. La proprietà è la garanzia che questa libertà sarà continua. La proprietà di una parte di ricchezza (strumento di lavoro) è possibilità di ampliare ancora il dominio della personale libertà. Il diritto di eredità è la garanzia che la tua personale libertà sarà anche della tua prole, dei tuoi cari. Poiché il tuo fine non è un circoscritto fatto materiale, poiché tu non sei un avido di benessere meccanico, ma di libertà, consegue che il tuo fine non è individuale: è un’immortalità. Senti che i tuoi figli ti continueranno, come tu continui i tuoi padri, e vuoi garantita la libertà del tuo spirito immortale. Questa immortalità è ammessa dai laici, dai filosofi: essa appunto è dai filosofi chiamata Spirito, e viene fatta coincidere con la Storia, perché tutto umano, perché non ha nulla da spartire con lo spirito (anima) trascendente, ultraterreno, delle religioni. È pura attività: tu sei attivo, lavori, partecipi dell’immortalità del lavoro, ma vuoi vedere esteriormente questa perennità del tuo io: la cerchi nei tuoi discendenti, nelle garanzie di libertà che loro assicuri.

Tutti gli uomini hanno questa aspirazione, tutti gli uomini vogliono diventare proprietari di libertà, di libertà garantita, di libertà trasmissibile. Se essa è il sommo bene, è naturale si cerchi di farne partecipi i propri cari, è naturale si accetti il sacrifizio per creare questa libertà, anche sicuri di non goderla se stessi, solo per assicurarla ai propri cari. La preoccupazione diventa in taluni casi così pungente da spingere al delitto, alla perversione, al suicidio. Madri si prostituiscono per racimolare un peculio di libertà ai figli; padri si uccidono con l’apparenza della disgrazia perché i figli godano subito l’assicurazione della libertà. La libertà è solo un privilegio: ecco perché si manifestano queste perversioni. La società è una fiera: la fortuna è una giostra. La maggioranza deve necessariamente fallire nella gara atroce. È dunque essa non-spirito, non partecipa essa della immortalità della storia? Esiste la immortalità senza l’esteriore continuità? Certo no. Esistendo, trasforma il mondo, suscita quindi forme esteriori. Ebbene, anche tu, che non sei ricco, che non sei capitalista, che non garantisci alla tua immortalità nessuna esteriore continuazione di libertà, erediti e lasci un retaggio. Non saresti uomo, altrimenti, non saresti spirito, non saresti storia. Bisogna che di questa verità tu abbia consapevolezza, che questa consapevolezza tu approfondisca in te e diffonda negli altri. Essa è la tua forza, è la chiave del tuo destino e del destino dei tuoi cari. La proprietà è il rapporto giuridico esistente tra un cittadino e un bene. Essa è dunque un valore sociale, puramente contingente; è garantita da tutti, che la garantiscono solo in quanto sperano, ognuno singolarmente, giungere a goderla. I pochi sono liberi, nel possesso dei beni, e trasmettono questa libertà ad altri pochi, perché i molti sperano, hanno la velleità di essere liberi, non ne hanno la volontà. La volontà è adeguazione dei mezzi al fine, quindi è specialmente ricerca di mezzi congrui. Il privilegio della libertà sussiste perché la società è una fiera, perché è un disordine perenne. La speranza che tu hai di saltare immediatamente in groppa a un cavallino della giostra, ti fa elemento del disordine, della perenne fiera: tu sei una rotellina della macchina infernale che fa roteare la giostra: se, nella gara, fallisci, tu sei causa del tuo fallire, se ti fiacchi le ossa, tu sei un suicida. Da elemento di disordine devi diventare elemento d’ordine. All’essere Immediatamente (vaga speranza, probabilità minima), devi preferire la certezza, anche se non immediata, la certezza per i tuoi figli. Il fine rimane immutato, i mezzi per raggiungerlo sono i soli mezzi congrui a tua disposizione: l’associazione, l’organizzazione. Se la proprietà è solo un valore sociale, il solo fatto che esiste un organismo-forza proponentesi di renderla bene comune, garanzia di libertà per tutti, la trasforma, la rende aleatoria in quanto privilegio, cioè la diminuisce ora in pro della collettività, ne fa compartecipe già ora la collettività. Questa diminuzione, questa compartecipazione potenziale è una eredità che tu trasmetti. Certo è più evidente, più palpabile l’eredità dei capitalisti; ma se rifletti anche la tua non è trascurabile cosa. Anche tu hai un retaggio: i tuoi ascendenti, che hanno fatto la rivoluzione contro il feudalismo, ti hanno lasciato in eredità il diritto alla vita (tu non puoi essere ucciso arbitrariamente: ti par piccola cosa?), la libertà individuale (per incarcerarti devi essere giudicato colpevole d’un crimine), il diritto di muoverti per lavorare in una terra piuttosto che in un’altra, a tua scelta, secondo la tua utilità. Godi una eredità più recente: la libertà di scioperare, la libertà di associarti con altri per discutere i tuoi interessi immediati e per proporti, in comunione con altri, il fine maggiore della tua vita: la libertà per te, o almeno per i tuoi discendenti. Ti paiono piccole eredità queste? Esse hanno notevolmente diminuito il privilegio dei pochi. Perché non ti proponi di ampliarle e diminuire ancora, conseguentemente, il privilegio? Queste eredità sono il frutto del lavoro di molti, non del solo padre tuo, del solo tuo nonno o bisnonno. Sono frutto inconsapevole, perciò piccolo. Diventa tu consapevole, diffondi la tua consapevolezza: quale eredità superiore a quelle del passato non trasmetterai tu all’avvenire? Quale più concreta sicurezza di libertà per i tuoi figli, per l’immortalità del tuo spirito? Invece di una proprietà individuale, preoccupati di lasciare maggiore possibilità per l’avvento della proprietà collettiva, della libertà per tutti, perché tutti uguali dinanzi al lavoro, allo strumento di lavoro. Questa tua eredità ha anch’essa una forma esteriore: l’associazione. Quanto più forte è l’associazione, tanto più vicina è l’ora di riscuotere allo sportello della storia. Chi riscuoterà? Tu stesso, forse, per la tua quota. Lavora come se il fine fosse immediato, ma non trascurare perciò di suscitare mezzi più potenti, nel caso non fosse immediato: sacrificati, perché tu pensi ai tuoi figli, ai tuoi cari. […] Diffondi questa piccola verità: nella società attuale, che è fiera, che è giostra, tutti singolarmente possono diventar ricchi (liberi), ma, necessariamente, solo pochi lo diventano; la ricerca della proprietà, dell’eredità individuale ha uno riuscito per diecimila falliti. I diecimila non falliranno invece nella ricerca dell’eredità sociale; che si associno, che da elemento di disordine diventino elemento d’ordine, e avranno avvicinato di diecimila probabilità il raggiungimento del fine stesso. Intanto tu fa il tuo dovere: dà la tua parte di attività, di spiritualità al comune patrimonio sociale attuale. lavora perché sia trasmesso, migliorato e ampliato, ai tuoi discendenti: cura la tua eredità, cura l’eredità che sola sei certo di poter lasciare».Consigliamo una particolare attenzione nella lettura di questo testo riguardante i temi della spontaneità e la direzione inconsapevole dei movimenti, con l conseguente necessità dell'avanguardia. Da sottolineare che Gramsci arriva autonomamente alle stesse conclusioni che si ritrovano in alcune opere di Lenin che Gramsci non aveva sicuramente letto:(da La tua eredità, Avanti!, 1 maggio 1918)
«non esiste nella storia la “pura” spontaneità: essa coinciderebbe con la “pura” meccanicità. Nel movimento “più spontaneo” gli elementi di “direzione consapevole” sono semplicemente incontrollabili, non hanno lasciato documento accertabile. Si può dire che l’elemento della spontaneità è perciò caratteristico della “storia delle classi subalterne” e anzi degli elementi più marginali e periferici di queste classi, che non hanno raggiunto la coscienza della classe “per sé” e che perciò non sospettano neanche che la loro storia possa avere una qualche importanza e che abbia un qualsiasi valore lasciarne tracce documentarie. Esiste dunque una “molteplicità” di elementi di “direzione consapevole” in questi movimenti, ma nessuno di essi è predominante, o sorpassa il livello della “scienza popolare” di un determinato strato sociale, del “senso comune” ossia della concezione del mondo [tradizionale] di quel determinato strato. […] Che in ogni movimento “spontaneo” ci sia un elemento primitivo di direzione consapevole, di disciplina, è dimostrato indirettamente dal fatto che esistono delle correnti e dei gruppi che sostengono la spontaneità come metodo. A questo proposito occorre fare una distinzione tra elementi puramente “ideologici”, ed elementi d’azione pratica, tra studiosi che sostengono la spontaneità come “metodo” immanente [ed obbiettivo] del divenire storico e politicanti che la sostengono come metodo “politico”. Nei primi si tratta di una concezione errata, nei secondi si tratta di una contraddizione [immediata e meschina] che lascia vedere l’origine pratica ed evidente, cioè la volontà [immediata] di sostituire una determinata direzione a un’altra. […]
Questa unità della “spontaneità” e della “direzione consapevole”, ossia della “disciplina” è appunto la azione politica reale delle classi subalterne, in quanto politica di massa e non semplice avventura di gruppi che si richiamano alla massa. Si presenta una quistione teorica fondamentale, a questo proposito: la teoria moderna può essere in opposizioni con i sentimenti “spontanei” delle masse? (“spontanei” nel senso che non dovuti a un’attività educatrice sistematica da parte di un gruppo dirigente già consapevole, ma formatosi attraverso l’esperienza quotidiana illuminata dal “senso comune” cioè dalla concezione tradizionale popolare del mondo, quello che molto pedestremente si chiama “istinto” e non è anch’esso che un’acquisizione storica primitiva ed elementare). Non può essere in opposizione: tra di essi c’è differenza “quantitativa”, di grado, non di qualità: deve essere possibile una “riduzione”, per così dire, reciproca, un passaggio dagli uni all’altra e viceversa. […]
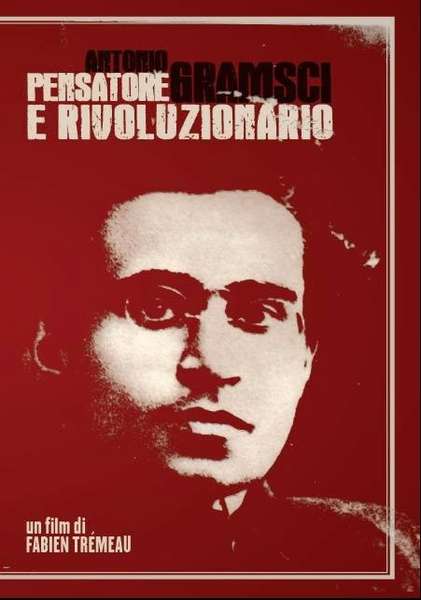
Trascurare e peggio disprezzare i movimenti così detti “spontanei”, cioè rinunziare a dar loro una direzione consapevole, ad elevarli ad un piano superiore inserendoli nella politica, può avere spesso conseguenze molto serie e gravi. Avviene quasi sempre che a un movimento “spontaneo” delle classi subalterne si accompagna un movimento reazionario della destra della classe dominante, per motivi concomitanti: una crisi economica, per esempio, determina malcontento nelle classi subalterne e movimenti spontanei di massa da una parte, e dall’altra determina complotti dei gruppi reazionari che approfittano dell’indebolimento obbiettivo del governo per tentare dei colpi di Stato. Tra le cause efficienti di questi colpi di Stato è da porre la rinunzia dei gruppi responsabili a dare una direzione consapevole ai moti spontanei e a farli diventare quindi un fattore politico positivo. […] I movimenti “spontanei” degli strati popolari più vasti rendono possibile l’avvento al potere della classe subalterna più progredita per l’indebolimento obbiettivo dello Stato. Questo è ancora un esempio “progressivo”, ma sono, nel mondo moderno, più frequenti gli esempi regressivi. La concezione storico-politica scolastica e accademica, per cui è reale e degno solo quel moto che è consapevole al cento per cento e che anzi è determinato da un piano minutamente tracciato in antecedenza o che corrisponde (ciò che è lo stesso) alla teoria astratta. Ma la realtà è ricca delle combinazioni più bizzarre ed è il teorico che deve in questa bizzarria rintracciare la riprova della sua teoria, “tradurre” in linguaggio teorico gli elementi della vita storica, e non viceversa la realtà presentarsi secondo lo schema astratto. Questo non avverrà mai e quindi questa concezione non è che una espressione di passività». (dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 3 [XX], voce 48, Passato e presente. Spontaneità e direzione consapevole)Sul rifiuto dell'astensionismo come tattica politica:
«È avvenuta parecchie volte questa trasposizione nel campo politico e parlamentare di concezioni nate sul terreno economico e sindacale. Ogni astensionismo politico si basa su questa concezione (astensionismo politico in generale, non solo parlamentare). Meccanicamente avverrà il crollo dell’avversario se, con metodo intransigente, lo si boicotterà nel campo governativo (sciopero economico, sciopero o inattività politica). L’esempio classico italiano è quello dei clericali dopo il 70. In realtà poi, dopo il 90 il non expedit fu temperato fino al patto Gentiloni, La fondazione del Partito Popolare segnò il rigetto totale di questo meccanicismo catastrofico».
(dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 1 [XVI], voce 53, Maurrasianismo e sindacalismo)
Sulla determinazione storico-sociale del concetto di “naturale”:
«Cosa significa dire che una certa azione, un certo modo di vivere, un certo atteggiamento o costume sono “naturali” o che essi invece sono “contro natura”? […] Occorre intanto fissare che non si può parlare di “natura” come di alcunché di fisso, immutabile ed oggettivo. Ci si accorge che quasi sempre “naturale” significa “giusto e normale” secondo la nostra attuale coscienza storica, ma i più non hanno coscienza di questa attualità determinata storicamente e ritengono il loro modo di pensare eterno e immutabile».
(dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 16 [XXII], voce 12, Naturale, contro natura, artificiale, ecc.)
E criticando invece i concetti di “convenzionale” e “artificiale”:
«Interessanti questi concetti di “convenzionale”, di “artificiale”, ecc., applicati a certe manifestazioni storiche: “convenzionale” e “artificiale” sono implicitamente contrapposti a “naturale”, cioè a uno schema “conservatore” veramente convenzionale e artificiale perché la realtà lo ha distrutto: in verità i peggiori “scientifisti” sono i reazionari che si proiettano una “evoluzione” di proprio comodo e ammettono l’importanza e l’efficacia dell’intervento della volontà umana fortemente organizzata e concentrata, solo quando è reazionaria, quando tende a restaurare ciò che è stato, come se ciò che è stato ed è stato distrutto non sia altrettanto “ideologico”, “astratto”, “convenzionale”, ecc., di ciò che ancora non è stato effettuato e anzi molto di più».
(dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 2 [XXIV], voce 91)

Sui termini di “politica” e “razionalità”:
«Ciò che è “politica” per la classe produttiva diventa “razionalità” per la classe intellettuale. Ciò che è strano è che dei marxisti ritengano superiore la “razionalità” alla “politica”, l'astrazione ideologica alla concretezza economica. Su questa base di rapporti storici è da spiegare l’idealismo filosofico moderno».
(dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 1 [XVI], voce 151, Rapporto storico tra lo Stato moderno francese nato dalla Rivoluzione e gli altri Stati moderni europei)
Sulla necessità di comprendere il ruolo potenzialmente progressivo dello Stato:
«Il concetto prettamente italiano di “sovversivo” può essere spiegato così: una posizione negativa e non positiva di classe: il “popolo” sente che ha dei nemici e li individua solo empiricamente nei così detti signori (nel concetto di “signore” c’è molto della vecchia avversione della campagna per la città, e il vestito è un elemento fondamentale di distinzione: c’è anche l’avversione contro la burocrazia, in cui si vede unicamente lo Stato: il contadino – anche il medio proprietario – odia il “funzionario” non lo Stato, che non capisce, e per lui è questo il “signore” anche se economicamente il contadino gli è superiore, onde l’apparente contraddizione per cui per il contadino il signore è spesso un “morto di fame”. Questo odio “generico” è ancora di tipo “semifeudale”, non moderno, e non può essere portato come documento di coscienza di classe: ne è appena il primo barlume, è solo, appunto, la posizione negativa e polemica elementare: non solo non si ha coscienza esatta della propria personalità storica, ma non si ha neanche coscienza della personalità storica e dei limiti precisi del proprio avversario. (Le classi inferiori, essendo storicamente sulla difensiva, non possono acquistare coscienza di sé che per negazioni, attraverso la coscienza della personalità e dei limiti di classe dell’avversario: ma appunto questo processo è ancora crepuscolare, almeno su scala nazionale). […] scarsa comprensione dello Stato significa scarsa coscienza di classe (comprensione dello Stato esiste non solo quando lo si difende, ma anche quando lo si attacca per rovesciarlo), quindi scarsa efficienza dei partiti ecc. Bande zingaresche, nomadismo politico non sono fatti pericolosi». (dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 3 [XX], voce 46, Passato e Presente)
Sui limiti del concetto di tolleranza, da non intendersi come la libertà di lasciar sbagliare:

«Si può essere intransigenti nell’azione solo se nella discussione si è stati tolleranti, e i più preparati hanno aiutato i meno preparati ad accogliere la verità, e le esperienze singole sono state messe in comune, e tutti gli aspetti del problema sono stati esaminati, e nessuna illusione è stata creata. Naturalmente questa tolleranza - metodo delle discussioni fra uomini che fondamentalmente sono d’accordo, e devono trovare le coerenze tra i principi comuni e l’azione che dovranno svolgere in comune - non ha che vedere con la tolleranza, intesa volgarmente. Nessuna tolleranza per l’errore, per lo sproposito. Quando si è convinti che uno è in errore - ed egli sfugge alla discussione, si rifiuta di discutere e di provare, sostenendo che tutti hanno il diritto di pensare come vogliono - non si può essere tolleranti. Libertà di pensiero non significa libertà di errare e spropositare. Noi siamo solo contro l’intolleranza che è un portato dell’autoritarismo o dell’idolatria, perché impedisce gli accordi durevoli, perché impedisce che si fissino delle regole d’azione obbligatorie moralmente perché al fissarle hanno partecipato liberamente tutti. Perché questa forma di intolleranza porta necessariamente alla transigenza, all’incertezza, alla dissoluzione degli organismi sociali».
(da Intransigenza - tolleranza. Intolleranza – transigenza, Il Grido del Popolo, 8 dicembre 1917)
Sulla differenza tra un anarchico e un comunista:
«Che differenza c’è tra un anarchico e un comunista marxista? L’anarchico rassomiglia a colui che prima di parlare... si guarda la lingua: egli fa programma politico della libertà che è tale solo in quanto non può essere ridotta a programma, cioè chiama libertà l’arbitrio, confondendosi col cristiano o col borghese liberale. Il comunista marxista è un materialista della storia: libertà significa per lui l’organizzazione delle condizioni in cui la libertà potrà essere realizzata».
(da Cosa intendiamo per Demagogia?, L’Ordine Nuovo, 29 Agosto 1920)
Contro il parolaismo degli anarchici:«I capi dell'anarchismo italiano hanno sempre stimolato più la nostra curiosità archeologica e folkloristica che la nostra attenzione di critici e di politici. […] I capi anarchici parlano di libertà in generale e di libertà in particolare: in verità essi ignorano cosa sia la libertà dell'una e dell'altra categoria. Il loro cervello è imbottito di frasi fatte […]. Errico Malatesta è il prototipo del “fanciullino” lettore di romanzi polizieschi dalla fantasia truculenta e lugubre, dal cervello imbottito di frasi fatte; egli è “libero” allo stesso modo che si può chiamare libera l'acqua di una pozzanghera limosa e popolata di gracidanti batraci in confronto all'acqua limpida e limitata “artificialmente” dal cristallo di una caraffa […]. Egli si crede permesso qualsiasi giudizio sul partito comunista e qualsiasi espressione cruda nei riguardi dei comunisti, ma se i comunisti rispondono per le rime si offende e urla e strepita e geme pateticamente. […] I comunisti sono: gente che aspetta di poter ammanettare, processare e... fucilare Malatesta e i suoi ammiratori; calunniatori, aspiranti al nobile mestiere di fornitori di carne umana alle galaìere e ai patiboli, tiranni bolscevichi, gente che ha la vocazione per fare i poliziotti sul serio!

Ai fascisti Malatesta riconosce ampia libertà di riunione e di manifestazione; ai comunisti non riconosce neppure la libertà di esporre, in articoli […] la loro dottrina che certamente non è la dottrina (!?) politica (!?) anarchica e afferma la necessità (propria di ogni Stato, e quindi anche dello Stato operaio) della costrizione, e cioè dell'esercito operaio, dei tribunali operai, delle galere dove chiudere i nemici dichiarati e irriducibili della classe operaia […]. La libertà per tutti, egregio e ottimo Malatesta, implica anche la libertà dei comunisti di giudicare con la propria testa e di stampare questi loro giudizi; implica anche la libertà vostra di crederci “fornitori di carne umana alle galere e ai patiboli”, così come implica la nostra libertà di non prendervi sul serio come guida spirituale del proletariato italiano e di catalogarvi tra le curiosità archeologiche e folkloristiche del nostro paese così ricco di curiosità e di belle tradizioni popolari. Luigi Fabbri, altrimenti conosciuto col truce soprannome di “Catilina”, è il prototipo del teologo da parrocchia rurale. Malatesta si sbriga di un argomento in venti righe “pittoresche”: Luigi Fabbri diluisce le venti righe in venti articoli di 200 righe l'uno, lunghe tiritere senza capo né coda, in cui la “semplicità” consiste solo in questo fatto: le cose realmente semplici, e quindi tali da essere afferrate facilmente dal Fabbri, vengono affogate in una profluvie di parole, di nessi logici inutili, di dimostrazioni oziose […].
Armando Borghi appartiene al decimo sommerso dell'anarchismo italiano. È fratello siamese di Giacinto Menotti Serrati: uomo senza carattere, bugiardo e sleale, della stirpe di Maramaldo. Tutti sapevano fin dal marzo 1919 che l'Internazionale comunista era una organizzazione politica, una organizzazione di partiti e di gruppi politici; tutti sapevano che i caposaldi dell'Internazionale comunista erano: la dittatura proletaria, cioè la organizzazione di uno Stato operaio accentrato e controllato dal Partito comunista; il potere industriale in mano non ai sindacati (cioè non in mano ai funzionari sindacali) ma ai Consigli economici popolari accentrati in un Consiglio economico nazionale; la creazione di un esercito rosso regolare e non la difesa della rivoluzione affidata all'iniziativa di individui o di bande disorganiche di partigiani. Armando Borghi conosceva o almeno aveva il dovere di conoscere queste cose. Egli aderì all'Internazionale comunista, egli fece aderire all'Internazionale politica l'Unione sindacale da lui guidata. […] Oggi Armando Borghi non solo è contro l'Internazionale comunista perché “politica” e “dittatoriale”, ma è contro l'Internazionale rossa dei sindacati perché “associata” all'Internazionale politica. Oggi Armando Borghi è ridiventato sindacalista anarchico e fa propaganda contro i “tiranni bolscevichi”, contro la dittatura che soffoca la rivoluzione, contro i partiti comunisti di cui non è diventato il presidente che suona energicamente il campanello. […] Egli creerà unioni sindacali all'infinito per essere segretario all'infinito; egli troverà sempre che tutte le organizzazioni di cui non è segretario non sono veramente rivoluzionarie e veramente proletarie. […] Libertà per tutti, se almeno così vi pare! Libertà per Errico Malatesta di ritenere i comunisti candidati ai mestieri tanto infamati e disonoranti di carnefice, di aguzzino, di poliziotto; e libertà ai comunisti di ritenere Malatesta semplice come la galletta di lungo corso. Libertà a Luigi Fabbri di fare la fontanella d'acqua potabile, e libertà ai comunisti di cercare di evitare l'inondazione e di non bere. Libertà ad Armando Borghi di fare il buffone, e libertà ai comunisti di scrivere che Armando Borghi è un buffone».
(da Libertà per tutti, se così almeno vi pare!, L'Ordine Nuovo, 23 novembre 1921)
Sul trasformismo degli uomini politici:
«una classe è dominante in due modi, e cioè “dirigente” e “dominante”. È dirigente delle classi alleate, è dominante delle classi avversarie. Perciò una classe già prima di andare al potere può essere “dirigente” (e deve esserlo): quando è al potere diventa dominante ma continua ad essere anche “dirigente”. […] il trasformismo è l'espressione politica di questa azione di direzione; tutta la politica italiana […] è caratterizzata dal “trasformismo”, cioè dall'elaborazione di una classe dirigente […] con l'assorbimento degli elementi attivi sorti dalle classi alleate e anche da quelle nemiche. La direzione politica diventa un aspetto di dominio, in quanto l'assorbimento delle élites delle classi nemiche porta alla decapitazione di queste e alla loro impotenza. Ci può e ci deve essere una “egemonia politica” anche prima della andata al Governo e non bisogna contare solo sul potere e sulla forza materiale che esso dà per esercitare la direzione o egemonia politica». (dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 1 [XVI], voce 44, Direzione politica di classe prima e dopo l'andata al governo)
Sul massimalismo e l'estremismo nemici del proletariato:
Sul massimalismo e l'estremismo nemici del proletariato:
«Il compagno Bordiga si offende perché è stato scritto che nella sua concezione c'è molto massimalismo. Non è vero, e non può essere vero - scrive Bordiga - Infatti il tratto più distintivo dell'estrema sinistra è l'avversione per il Partito massimalista, che ci fa schifo, ci fa vomitare, ecc. ecc. La quistione però è un'altra. Il massimalismo è una concezione fatalistica e meccanica della dottrina di Marx. C'è il Partito massimalista che da questa concezione falsificata trae argomento per il suo opportunismo, per giustificare il suo collaborazionismo larvato da frasi rivoluzionarie. Bandiera rossa trionferà perché è fatale e ineluttabile che il proletariato debba vincere; l'ha detto Marx, che è il nostro dolce e mite maestro! É inutile che ci muoviamo; a che pro muoversi e lottare se la vittoria è fatale e ineluttabile? Così parla un massimalista del Partito massimalista. Ma c'è anche il massimalista che non è nel Partito massimalista, e che può essere invece nel Partito comunista.
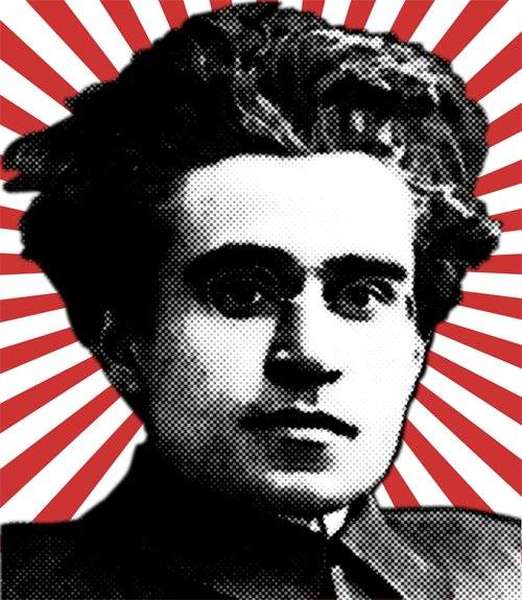
Egli è intransigente, e non opportunista. Ma anche egli crede che sia inutile muoversi e lottare giorno per giorno; egli attende solo il grande giorno. Le masse - egli dice - non possono non venire a noi, perché la situazione oggettiva le spinge verso la rivoluzione. Dunque attendiamole, senza tante storie di manovre tattiche e simili espedienti. Questo, per noi, è massimalismo, tale e quale come quello del Partito massimalista. Il compagno Lenin ci ha insegnato che per vincere il nostro nemico di classe, che è potente, che ha molti mezzi e riserve a sua disposizione, noi dobbiamo sfruttare ogni incrinatura nel suo fronte e dobbiamo utilizzare ogni alleato possibile, sia pure incerto, oscillante e provvisorio. Ci ha insegnato che nella guerra degli eserciti, non può raggiungersi il fine strategico, che è la distruzione del nemico e l'occupazione del suo territorio, senza aver prima raggiunto una serie di obiettivi tattici tendenti a disgregare il nemico prima di affrontarlo in campo. Tutto il periodo prerivoluzionario si presenta come un'attività prevalentemente tattica, rivolta ad acquistare nuovi alleati al proletariato, a disgregare l'apparato organizzativo di offesa e di difesa del nemico, a rilevare e ad esaurire le sue riserve. Non tener conto di questo insegnamento di Lenin, o tenerne conto solo teoricamente, ma senza metterlo in pratica, senza farlo diventare azione quotidiana, significa essere massimalisti, cioè pronunziare grandi frasi rivoluzionarie, ma essere incapaci a muovere un passo nella via della rivoluzione».(da Massimalismo ed estremismo, L'Unità, 2 luglio 1925)
Perché allora l'uomo del popolo non diventa immediatamente comunista quando gli spieghiamo le cose?
«nelle masse in quanto tali la filosofia non può essere vissuta che come una fede. Si immagini del resto la posizione intellettuale di un uomo del popolo; egli si è formato delle opinioni, delle convinzioni, dei criteri di discriminazione e delle norme di condotta. Ogni sostenitore di un punto di vista contrastante al suo, in quanto è intellettualmente superiore, sa argomentare le sue ragioni meglio di lui, lo mette in sacco logicamente ecc.; dovrebbe perciò l’uomo del popolo mutare le sue convinzioni? Perché nell’immediata discussione non sa farsi valere? ma allora gli potrebbe capitare di dover mutare una volta al giorno, cioè ogni volta che incontra un avversario ideologico intellettualmente superiore. Su quali elementi si fonda dunque la sua filosofia? e specialmente la sua filosofia nella forma che per lui ha maggiore importanza di norma di condotta? L’elemento più importante è indubbiamente di carattere non razionale, di fede. Ma in chi e che cosa? Specialmente nel gruppo sociale al quale appartiene in quanto la pensa diffusamente come lui: l’uomo del popolo pensa che in tanti non si può sbagliare, così in tronco, come l’avversario argomentatore vorrebbe far credere; che egli stesso, è vero, non è capace di sostenere e svolgere le proprie ragioni come l’avversario le sue, ma che nel suo gruppo c’è chi questo saprebbe fare, certo anche meglio di quel determinato avversario ed egli ricorda infatti di aver sentito esporre diffusamente, coerentemente, in modo che egli ne è rimasto convinto, le ragioni della sua fede. Non ricorda le ragioni in concreto e non saprebbe ripeterle, ma sa che esistono perché le ha sentite esporre e ne è rimasto convinto. L’essere stato convinto una volta in modo folgorante è la ragione permanente del permanere della convinzione, anche se essa non si sa più argomentare. Ma queste considerazioni conducono alla conclusione di una estrema labilità nelle convinzioni nuove delle masse popolari, specialmente se queste nuove convinzioni sono in contrasto con le convinzioni (anche nuove) ortodosse, socialmente conformiste secondo gli interessi generali delle classi dominanti. Si può vedere questo riflettendo alle fortune delle religioni e delle chiese. […] Se ne deducono determinate necessità per ogni movimento culturale che tenda a sostituire il senso comune e le vecchie concezioni del mondo in generale:
1) di non stancarsi mai dal ripetere i propri argomenti (variandone letterariamente la forma): la ripetizione è il mezzo didattico più efficace per operare sulla mentalità popolare;
2) di lavorare incessantemente per elevare sempre più vasti strati popolari, cioè per dare personalità all’amorfo elemento di massa, ciò che significa lavorare a suscitare élites di intellettuali di un tipo nuovo che sorgano direttamente dalla massa pur rimanendo a contatto con essa per diventarne le “stecche” del busto». (dai Quaderni dal Carcere, quaderno 11 (XVIII), voce 12, Appunti per una introduzione e un avviamento allo studio della filosofia e della storia della cultura)
Sulla complessa dialettica della comunicazione e dell'apprendimento politico:
«Passaggio dal sapere al comprendere al sentire e viceversa dal sentire al comprendere al sapere. L’elemento popolare “sente”, ma non comprende né sa; l’elemento intellettuale “sa” ma non comprende e specialmente non sente. I due estremi sono dunque la pedanteria e il filisteismo da una parte e il settarismo dall’altra. Non che il pedante non possa essere appassionato, tutt’altro: la pedanteria appassionata è altrettanto ridicola e pericolosa che il settarismo o la demagogia appassionata. L’errore dell’intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere e specialmente senza sentire ed essere appassionato, cioè che l’intellettuale possa esser tale se distinto e staccato dal popolo: non si fa storia-politica senza passione, cioè senza essere sentimentalmente uniti al popolo, cioè senza sentire le passioni elementari del popolo, comprendendole, cioè spiegandole [e giustificandole] nella determinata situazione storica e collegandole dialetticamente alle leggi della storia, cioè a una superiore concezione del mondo, scientificamente elaborata, il “sapere”. Se l’intellettuale non comprende e non sente, i suoi rapporti col popolo-massa sono o si riducono a puramente burocratici, formali: gli intellettuali diventano una casta o un sacerdozio (centralismo organico): se il rapporto tra intellettuali e popolo-massa, tra dirigenti e diretti, tra governanti e governati, è dato da una adesione organica in cui il sentimento passione diventa comprensione e quindi sapere (non meccanicamente, ma in modo vivente), allora solo il rapporto è di rappresentanza, e avviene lo scambio di elementi individuali tra governati e governanti, tra diretti e dirigenti, cioè si realizza la vita d’insieme che sola è la forza sociale, si crea il “blocco storico”». (dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 4 [XIII], voce 33)
Su come creare coscienza di classe evitando gli errori “illuministici” più comuni:
«La elaborazione unitaria di una coscienza collettiva domanda condizioni e iniziative molteplici. La diffusione da un centro omogeneo di un modo di pensare e di operare omogeneo è la condizione principale, ma non deve essere e non può essere la sola. Un errore molto diffuso consiste nel pensare che ogni strato sociale elabori la sua coscienza e la sua cultura allo stesso modo, con gli stessi metodi, cioè i metodi degli intellettuali di professione. […]
È illusorio attribuire a tutti questa capacità “acquisita” e non innata. È illusorio pensare che una “idea chiara” opportunamente diffusa si inserisca nelle diverse coscienze con gli stessi effetti organizzatori di chiarezza diffusa. È un errore illuministico. La capacità dell'intellettuale di professione di combinare abilmente l'induzione e la deduzione, di generalizzare, di dedurre, di trasportare da una sfera a un'altra un criterio di discriminazione, adattandolo alle nuove condizioni, ecc. è una “specialità”, non è un dato del senso comune. […] Il lavoro educativo-formativo che un centro omogeneo di cultura svolge, l'elaborazione di una coscienza critica che esso promuove e favorisce su una determinata base storica che contenga le premesse materiali a questa elaborazione, non può limitarsi alla semplice enunciazione teorica di principi “chiari” di metodo; questa sarebbe pura azione “illuministica”. Il lavoro necessario è complesso e deve essere articolato e graduato: ci deve essere la deduzione e l'induzione combinate, l'identificazione e la distinzione, la dimostrazione positiva e la distruzione del vecchio. Ma non in astratto, in concreto: sulla base del reale. […] In questo senso ordine di osservazioni si inserisce un criterio più generale: i mutamenti nei modi di pensare, nelle credenze, nelle opinioni, non avvengono per “esplosioni” rapide e generalizzate, avvengono per lo più per “combinazioni successive” secondo “formule” disparatissime. L'illusione “esplosiva” nasce da assenza di spirito critico».
(dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 1 [XVI], voce 43, Riviste tipo)
Sugli intellettuali:
«Non esiste una classe indipendente di intellettuali, ma ogni classe ha i suoi intellettuali: però gli intellettuali della classe storicamente progressiva esercitano un tale potere di attrazione, che finiscono, in ultima analisi, col subordinarsi gli intellettuali delle altre classi e col creare l'ambiente di una solidarietà di tutti gli intellettuali con legami di carattere psicologico (vanità, ecc.) e spesso di casta (tecnico-giuridici, corporativi)». (dai Quaderni dal Carcere, Quaderno I [XVI], voce 44, Direzione politica e di classe prima e dopo l'andata al governo)

Sulle tendenze di degenerazione della scuola:
«Nella scuola moderna mi pare stia avvenendo un processo di progressiva degenerazione: la scuola di tipo professionale, cioè preoccupata di un immediato interesse pratico, prende il sopravvento sulla scuola “formativa” immediatamente disinteressata. La cosa più paradossale è che questo tipo di scuola appare e viene predicata come “democratica”, mentre invece essa è proprio destinata a perpetuare le differenze sociali. […] Il carattere sociale della scuola è dato dal fatto che ogni strato sociale ha un proprio tipo di scuola destinato a perpetuare in quello strato una determinata funzione tradizionale. Se si vuole spezzare questa trama, occorre dunque non moltiplicare e graduare i tipi di scuola professionale, ma creare un tipo unico di scuola preparatoria (elementare-media) che conduca il giovane fino alla soglia della scelta professionale, formandolo nel frattempo come uomo capace di pensare, di studiare, di dirigere o di controllare chi dirige. Il moltiplicarsi di tipi di scuole professionali tende dunque a eternare le differenze tradizionali, ma siccome, in esse, tende anche a creare nuove stratificazioni interne, ecco che nasce l'impressione della tendenza democratica. […] Ma la tendenza democratica, intrinsecamente, non può solo significare che un manovale diventi operaio qualificato, ma che ogni “cittadino” può diventare “governante” e che la società lo pone sia pure astrattamente nelle condizioni generali di poterlo diventare […]. Anche lo studio è un mestiere e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio anche nervoso-muscolare, oltre che intellettuale: è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo e il dolore e la noia. La partecipazione di più larghe masse alla scuola media tende a rallentare la disciplina dello studio, a domandare facilitazioni. Molti pensano addirittura che la difficoltà sia artificiale, perché sono abituati a considerare lavoro e fatica solo il lavoro manuale. È una quistione complessa. Certo il ragazzo di una famiglia tradizionalmente di intellettuali supera più facilmente il processo di adattamento psicofisico: egli già entrando la prima volta in classe ha parecchi punti di vantaggio sugli altri scolari, ha un'ambientazione già acquisita per le abitudini famigliari. Così il figlio di un operaio di città soffre meno entrando in fabbrica di un ragazzo di contadini o di un contadino già sviluppato per la vita dei campi. […] Ecco perché molti del popolo pensano che nella difficoltà dello studio ci sia un trucco a loro danno; vedono il signore […] compiere con scioltezza e con apparente facilità il lavoro che ai loro figli costa lacrime e sangue, e pensano ci sia un trucco. In una nuova situazione politica, queste quistioni diventeranno asprissime e occorrerà resistere alla tendenza di rendere facile ciò che non può esserlo senza essere snaturato. Se si vorrà creare un nuovo corpo di intellettuali, fino alle più alte cime, da uno strato sociale che tradizionalmente non ha sviluppato le attitudini psico-fisiche adeguate, si dovranno superare difficoltà inaudite». (dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 4 [XIII], voce 55, Il principio educativo nella scuola elementare e media)
Su come riorganizzare la scuola italiana:
«Prendendo come tipo di riferimento la attuale scuola classica: 1) elementari, 2) ginnasio, 3) liceo, 4) università con le specializzazioni professionali, teoretiche o pratiche si può dire che la scuola unitaria comprenderebbe i primi tre gradi riorganizzati, non solo per il contenuto e il metodo dell’insegnamento, ma anche per la disposizione della carriera scolastica. Le elementari dovrebbero essere di tre-quattro anni e insegnare dogmaticamente (sempre in modo relativo) i primi elementi della nuova concezione del mondo, lottando contro la concezione del mondo data dall’ambiente tradizionale (folklore in tutta la sua estensione) oltre [a dare], s’intende, gli strumenti primordiali della cultura: leggere, scrivere, far di conto, nozioni di geografia, storia, diritti e doveri (cioè prime nozioni sullo Stato e la società). Il ginnasio potrebbe essere ridotto a quattro anni e il liceo a due, in modo che un bambino che è entrato a scuola a sei anni potrebbe a quindici-sedici anni aver percorso tutta la scuola unitaria. […] Il problema fondamentale si pone in quella fase dell’attuale carriera scolastica che oggi è rappresentata dal liceo, e che oggi non si differenzia per nulla, come tipo di insegnamento, dalle classi precedenti, altro che per la supposizione di una maggiore maturità intellettuale e morale dell’allievo come un portato della maggiore età e dell’esperienza accumulata precedentemente. Di fatto però tra liceo e università c’è un salto, una vera soluzione di continuità, non una passaggio normale dalla quantità (età) alla qualità (maturità intellettuale e morale). Dall’insegnamento quasi puramente ricettivo si passa alla scuola creativa; dalla scuola con disciplina dello studio imposta e controllata dal di fuori si passa alla scuola in cui l’autodisciplina [intellettuale] e l’autonomia morale è teoricamente illimitata. E ciò avviene subito dopo la crisi della pubertà, quando la foga delle passioni istintive ed elementari non ha ancora finito di lottare coi freni del carattere e della coscienza morale. […] Ecco dunque che nella scuola unitaria la fase del Liceo deve essere concepita come la fase transitoria più importante in cui la scuola tende a creare i valori fondamentali dell’“umanesimo”, l’autodisciplina intellettuale e l’autonomia morale necessarie per l’ulteriore specializzazione, sia che essa sia di carattere immediatamente pratico-produttivo (industria, organizzazione degli scambi, burocrazia ecc.). Lo studio del metodo scientifico deve cominciare nel Liceo e non essere più un monopolio dell’Università: il Liceo deve essere già un elemento fondamentale dello studio creativo e non solo ricettivo (io faccio una differenza tra scuola creativa e scuola attiva: tutta la scuola universitaria è scuola attiva, mentre la scuola creativa è una fase, il coronamento della scuola attiva. Naturalmente sia scuola attiva che scuola creativa devono essere intese rettamente: la scuola attiva, dalla fase romantica in cui gli elementi della lotta contro la scuola meccanica e gesuitica si sono dilatati morbosamente per ragioni di contrasto e di polemica, deve trovare e raggiungere la fase classica, liberata dagli elementi spuri polemici e che trova in se stessa e nei fini che vuole raggiungere la sua ragione di essere e l’impulso a trovare le sue forme e i suoi metodi. Così la scuola creativa non significa scuola di “inventori e scopritori” di fatti ed argomenti originali in senso assoluto, ma scuola in cui la “recezione” avviene per uno sforzo spontaneo e autonomo dell’allievo e in cui il maestro esercita specialmente una funzione di controllo e di guida amichevole come avviene, o dovrebbe avvenire oggi nelle Università. Scoprire da se stessi, senza suggerimenti e impulsi esterni, una verità è “creazione”, anche se la verità è vecchia».(dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 4 [XIII], voce 50, La scuola unitaria)
Da ricordare a tutti quelli che suggeriscono il “voto utile” per farti votare le destre liberali rispetto a quelle xenofobe-razziste. Ma anche a quelli che propongono di costruire sinistre-scatoloni antiliberiste invece di impegnarsi nell'opera di ricostruzione del partito comunista:
«Un male è sempre minore di un altro susseguente possibile maggiore. Ogni male diventa minore in confronto di un altro che si prospetta maggiore e così all’infinito. La formula del male minore, del meno peggio, non è altro dunque che la forma che assume il processo di adattamento a un movimento storicamente regressivo, movimento di cui una forza audacemente efficiente guida lo svolgimento, mentre le forze antagonistiche (o meglio i capi di esse) sono decise a capitolare progressivamente, a piccole tappe e non di un solo colpo (ciò che avrebbe ben altro significato, per l’effetto psicologico condensato, e potrebbe far nascere una forza concorrente attiva a quella che passivamente si adatta alla “fatalità”, o rafforzarla se già esiste)».(dai Quaderni dal carcere, Quaderno 16 (XXII), voce 25, Il male minore e il meno peggio)

Sulle accuse di “populismo e demagogia”, scagliate da sempre su chi mette in discussione il capitalismo e il potere borghese:
«Demagogico e demagogia sono le due parole più in voga presso le persone ben pensanti e i pietisti in pantofole per dare il colpo di grazia all’attività dei “caporioni”, dei “sobillatori” socialisti. Demagogia, […] noi continuiamo a dare alla parola il suo vecchio significato, e continuiamo ad applicarla ai demagoghi, cioè a quelli che si servono di sgambetti logici per apparire nel vero, che falsano scientemente i fatti per apparire i trionfatori, che per ubriacarsi della vittoria di un istante sono insinceri o affrettati. Ci hanno chiamato demagoghi perché ci piace chiamare “pescicani” i fornitori militari. […] Siamo “demagoghi” perché non ci lasciamo guidare nelle nostre valutazioni dal criterio dell’utile, evviva dunque la demagogia. Siamo demagoghi perché non siamo imbecilli, perché non vogliamo confondere l’inconfondibile. […] Perché non muoviamo dalle apparenze fallaci, perché non giudichiamo dal criterio dell’utile immediato, siamo demagoghi, e gli altri sono persone serie, maestri di bel vivere. Con questi capovolgimenti di senso comune si dimostra la nostra disonestà, la nostra demagogia. E si contribuisce niente altro che a una trasformazione dei significati delle parole del vocabolario italiano».
(da Demagogia, Avanti!, ediz. Piemontese, 10 ottobre 1917, nella rubrica Sotto la Mole)

Sulla nascita del mito razzista del meridionale fannullone:
«La miseria del Mezzogiorno era inspiegabile storicamente per le masse popolari del Nord: queste non capivano che l'unità non era stata creata su una base di eguaglianza, ma come egemonia del Nord sul Sud nel rapporto territoriale città campagna, cioè che il Nord era una “piovra” che si arricchiva alle spese del Sud, che l'incremento industriale era dipendente dall'impoverimento dell'agricoltura meridionale. Esse invece pensavano che se il Mezzogiorno non progrediva dopo essere stato liberato dagli impacci che allo sviluppo moderno opponeva il borbonismo, ciò significava che le cause della miseria non erano esterne ma interne; poiché d'altronde era radicata la persuasione della grande ricchezza naturale del terreno, non rimaneva che una spiegazione, l'incapacità organica degli uomini, la loro barbarie, la loro inferiorità biologica. Queste opinioni già diffuse (il lazzaronismo napoletano era una leggenda di vecchia data) furono consolidate e teorizzate addirittura dai sociologhi del positivismo assumendo la forza di verità scientifiche in un tempo di superstizione della scienza. Si ebbe così una polemica Nord-Sud sulle razze e sulle superiorità e inferiorità del Settentrione e del Mezzogiorno […]. Intanto rimase nel Nord la credenza della palla di piombo che il Mezzogiorno rappresenterebbe per l'Italia, la persuasione dei più grandi progressi che la civiltà moderna industriale del Nord avrebbe fatto senza questa palla di piombo, ecc». (dai Quaderni dal Carcere, Quaderno I, voce 44, Direzione politica di classe prima e dopo l'andata al governo)
Sul concetto di ortodossia:
«L’ortodossia non deve essere ricercata in questo o quello dei discepoli di Marx, in quella o questa tendenza legata a correnti estranee al marxismo, ma nel concetto che il marxismo basta a se stesso, contiene in sé tutti gli elementi fondamentali, non solo per costruire una totale concezione del mondo, una totale filosofia, ma per verificare una totale organizzazione pratica della società, cioè per diventare una integrale, totale civiltà. Questo concetto così rinnovato di ortodossia, serve a precisare meglio l’attributo di “rivoluzionaria” attribuito a una concezione del mondo, a una teoria. Il cristianesimo fu rivoluzionario in confronto del paganesimo perché fu un elemento di scissione completa tra i sostenitori del vecchio e del nuovo mondo. Una teoria è rivoluzionaria in quanto è appunto elemento di separazione completa in due campi, in quanto è vertice inaccessibile agli avversari. Ritenere che il materialismo storico non sia una struttura di pensiero completamente autonoma significa in realtà non avere completamente tagliato i legami col vecchio mondo. In realtà, il materialismo storico non ha bisogno di sostenitori eterogenei: esso stesso è così robusto, che il vecchio mondo vi ricorre per fornire il suo arsenale di qualche arma più efficace. Ciò significa che mentre il materialismo storico non subisce egemonie, incomincia esso stesso ad esercitare una egemonia sul vecchio mondo intellettuale. Ciò avviene in forme reciproche naturalmente, ma è appunto ciò che bisogna sventare. Il vecchio mondo, rendendo omaggio al materialismo storico cerca di ridurlo a un corpo di criteri subordinati, di secondo grado, da incorporare nella sua teoria generale, idealistica o materialistica: chi riduce a un ruolo simile il materialismo storico nel campo proprio di questa teoria, capitola implicitamente dinanzi agli avversari».(dai Quaderni dal Carcere, Quaderno 4 [XIII], voce 14, Il concetto di ortodossia)
Infine il suo brano più famoso, teso a risvegliare la volontà umana dall'indifferenza:
«Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che “vivere vuol dire essere partigiani”. Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. È la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità; e ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all'intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all'iniziativa dei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell'ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile.

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere. Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti».(da Indifferenti, La città futura, 11 febbraio 1917)