3.02. L'ATTENTATO A TOGLIATTI DEL 14 LUGLIO 1948
«Che fesso, m'ha sparato quattro colpi e non mi ha finito».
(prime parole di Palmiro Togliatti dopo aver ripreso coscienza a seguito dell'attentato subito)134
Vediamo ora l'episodio dell'attentato a Togliatti secondo due differenti prospettive.
Di seguito Franco Astengo135, che giudica positivamente il comportamento della dirigenza:
Di seguito Franco Astengo135, che giudica positivamente il comportamento della dirigenza:
«Il 14 luglio 1948 l’attentato al segretario del PCI, Palmiro Togliatti, scosse profondamente l’Italia e il mondo, in una fase di fortissima contrapposizione fra le due grandi potenze, quella americana e quella sovietica, che avevano appena avviato il confronto della “guerra fredda” e di assoluta fragilità della democrazia italiana, appena ricostruita dopo la tragedia della guerra, attraverso il lavoro dell’Assemblea Costituente: pochi mesi prima, il 14 aprile, una tesissima campagna elettorale che aveva visto contrapposti la visione “liberal-atlantica” della Democrazia Cristiana, appoggiata dalla Chiesa Cattolica che uso tutte le sue possibili sfere d’influenza, e il Fronte Democratico Popolare, formato da comunisti e socialisti, si era conclusa con la maggioranza assoluta assegnata alla DC, in un clima di rivendicazioni sociali molto forti, dettate dalle precarie condizioni di vita di gran parte della popolazione. La reazione della base comunista fu fortissima: ma si verificò davvero il rischio di arrivare alla guerra civile e, soprattutto, quale fu l’esito sul piano politico al riguardo delle prospettive in quel momento della situazione politica italiana? Lo sciopero generale che seguì la notizia dell’attentato a Togliatti è stato giudicato da autorevoli osservatori come “lo sciopero generale più completo e più esteso che si sia mai avuto nella storia d’Italia” (Sergio Turone: Storia del Sindacato in Italia 1943-1969. Dalla Resistenza all’autunno caldo, Laterza 1973) La base comunista aveva interpretato, senza esitazioni, l’attentato a Togliatti come l’atto estremo di una reazione volta a cancellare il PCI: gli altri si chiudono in casa e le forze dell’ordine appaiono, subito, prive di ordini precisi. La mattina presto Togliatti ha partecipato a una riunione della Segreteria con Longo, Secchia e Scoccimarro, poi si è recato alla Camera uscendone verso le 11,30 dal portone secondario di via della Missione, accompagnato da Nilde Jotti. Un giovane vestito di blu lo raggiunge di corsa e spara. Antonio Pallante, l’attentatore è subito arrestato. I rapporti riservati della polizia, che l’ambasciata USA a Roma ha potuto esaminare, lo descrivono come un isolato e valgono a fugare il sospetto di una trama più vasta. Al processo Pallante dichiarò: “Sul giornale del PSDI Togliatti era descritto come un uomo infausto, pericoloso per l’Italia, da 'inchiodare al muro'. E il capo del PCI annunciava di essere pronto a prendere a calci De Gasperi. Ecco, esaltato da tutto questo, decisi di eliminare il pericolo” (intervista di Antonio Pallante, rilasciata a Pino Aprile di Oggi il 19 maggio 1988). Processato nel luglio 1949 e condannato a 13 anni, Pallante uscì dal carcere nel dicembre 1953 e tornò a Catania dove trovò lavoro come guardia forestale. La notizia dell’attentato a Togliatti rimbombò immediatamente in Parlamento, cogliendo tutto di sorpresa. Secchia e Longo seguirono Togliatti al Policlinico. Non ci fu bisogno di proclamare lo sciopero generale, che partì spontaneamente anche nelle sedi più periferiche, esterne al gruppo dirigente centrale, come emerge dalle testimonianze inserite nel volume di Gozzini e Martinelli: Storia del Partito Comunista Italiano: dall’attentato a Togliatti, all’VIII Congresso (Einaudi, 1998). Sull’onda di questo quadro, apparentemente tumultuoso e incontrollabile, la Direzione del PCI si riunì in un clima di grande incertezza derivante non soltanto dalle condizioni fisiche di Togliatti, ma anche e soprattutto al riguardo delle valutazioni inerenti il tipo di attacco cui era sottoposto, in quel momento, il Partito. Emerse subito un orientamento unitario: quello di una risposta forte ma ordinata, che predisponesse una linea di difesa organizzativa e militare contro ogni tipo di aggressione. Una seconda linea di dirigenti (Barontini a Livorno, Pellegrini a Venezia, Spano a Genova) fu inviata nelle situazioni che si annunciavano come le più difficili. Fu emesso un comunicato chiedendo le dimissioni del governo e Ingrao preparò per l’Unità un titolo Via il governo della guerra civile: entrambi gli atti sottolineavano, oggettivamente, il carattere pacifico della protesta. Al tempo stesso la non definizione di obiettivi immediati fu testimoniata dallo stesso comunicato con cui la CGIL proclamò (a posteriori) lo sciopero generale “in attesa di ulteriori disposizioni”. A spingere verso la moderazione ci fu, senza dubbio, anche la stessa voce di Togliatti all’atto del ferimento: il suo invito a stare calmi e a non perdere la testa. La Camera si riunì in una tempestosa seduta, nel corso della quale De Gasperi espresse la preoccupazione e l’ansia per “l’atmosfera di odi e di risentimenti, che l’esecrando attentato avrebbe potuto innescare”.

La ricostruzione della geografia del moto popolare che scosse, in quel momento, l’Italia appare come una geografia frastagliata e, di conseguenza, di per stessa significativa. Secondo i dati esposti dal ministro dell’Interno Scelba, nella seduta del Senato del 20 luglio, il bilancio complessivo degli scontri contò 16 morti (7 civili e 9 agenti di polizia) e oltre duecento feriti, concentrati nelle maggiori realtà urbane del Centro-Nord, con la vistosa eccezione del paese di Abbadia San Salvatore, alle pendici del monte Amiata. Al Sud si verificarono scontri tra dimostranti e polizia a Napoli, Salerno e Taranto, tentativi di blocco del traffico a Cagliari, manifestazioni e scioperi riusciti a Cosenza, Vibo Valentia, Crotone, Messina e Sassari; le sedi della DC furono devastate a Foggia, Lecce, Messina, Matera e Salerno. Il quadro fornito dal Mezzogiorno è quello di un movimento di protesta non particolarmente organizzato, che non prende di mira i centri del potere istituzionale. Diverso è il quadro delle città del triangolo industriale: Genova, che rappresenta il caso estremo, fu isolata fin dalle prime ore del pomeriggio da una serie di posti di blocco nelle principali vie d’accesso all’abitato: apparve chiaro il dispiegarsi di un’attività coordinata di presidio del territorio organizzato per difendere la Città da attacchi esterni: una struttura di ordini e di comando elaborata in caso di colpo di Stato, quindi in funzione difensiva (cfr: Paride Rugafiori, in A.V., Genova, il triangolo industriale tra ricostruzione e lotta di classe 1945–1948, Feltrinelli 1974). A Milano, Torino, Venezia, l’esistenza di questo piano di difesa appare avvalorata dall’immediata occupazione delle fabbriche più importanti: alla Fiat rimane al suo posto, nella fabbrica occupata, anche il presidente Valletta. Blocchi stradali comparirono anche alla periferia di Roma e nelle campagne toscane; i binari delle ferrovie furono interrotti a Foligno, Fidenza, Massarosa. Il grosso delle azioni offensive verso le sedi di partiti di governo si verificarono nella notte tra il 14 e il 15 luglio a Roma, Viterbo, Udine, Forlì, Reggio Emilia, Ferrara, La Spezia, Pistoia, Savona, Cesena, Venezia, Varese, Civitavecchia, Padova e Perugia. A Piombino fu assaltata la caserma dei carabinieri e quella della guardia di finanza chiedendo la consegna delle armi e a Busto Arsizio si tentò, senza successo, un assalto alle carceri nelle quali erano rinchiusi partigiani condannati per atti di guerra. La mattina del 15 luglio la CGIL, con DI Vittorio appena rientrato dalla Conferenza Internazionale del lavoro di San Francisco, si incontrò con De Gasperi, aprendo la trattativa per il rientro dallo sciopero. L’esecutivo della Confederazione, assente la componente democristiana che stava già preparando la scissione “libertina”, emise un comunicato fissando la fine delle agitazioni per il mezzogiorno del 16 luglio: l’ordine fu eseguito anche se, in particolare a Milano e Torino, la “normalizzazione” incontrò serie difficoltà. A sciopero finito la Direzione del PCI rivolse un nuovo appello per cercare un equilibrio tra la valorizzazione della combattività delle masse e la preoccupazione di rientrare nell’ambito di una politica costituzionale. È questo il punto politico “vero” di questa vicenda, sul quale è il caso, ancor oggi, di soffermarsi nell’analisi. La domanda è questa: si può sostenere, sulla base di ciò che avvenne attorno a quel drammatico 14 luglio 1948, che si ebbe una “delle maggiori dimostrazioni della 'doppiezza' comunista intesa non solo come duplicità di impostazioni tattico – strategiche, ma anche proprio come scontro di linee tra anime diverse del partito?” (tesi sostenuta da diversi autori, da Pinzani a Di Loreto a Simona Colarizi). Nell’emergenza drammatica del luglio 1948 il gruppo dirigente del PCI si dimostrò unito dimostrando come, nei tempi brevi della politica, il partito fosse legato prima di tutto a una sostanziale adesione alle regole e ai meccanismi di funzionamento della Costituzione repubblicana. È innegabile però che, da quel frangente, il sistema politico restasse diviso da una profonda linea di frattura suscitata dal sospetto reciproco sulle intenzioni antidemocratiche dell’avversario: una linea di frattura che riprendeva e allargava quella più generale determinata dalla guerra fredda e dalla logica dei blocchi. La contraddizione più significativa che era emersa, però, da quelle giornate riguardava invece il complesso della cultura politica patrimonio del Partito. Il comportamento pratico osservato dal PCI nell’emergenza non aveva sicuramente significato che la cultura del gruppo dirigente e del corpo militante esprimesse una completa adesione ai valori della democrazia: ma fu in quell’occasione che prevalse chiaramente la linea, il cui concretizzarsi rappresentava la massima preoccupazione di Togliatti, quella della “legittimazione nazionale del Partito”, quella del suo pieno inserimento nei gangli del meccanismo sociale, politico, istituzionale, per far vivere davvero il “partito nuovo” e porlo al riparo dal rischio di un inasprirsi secco della repressione poliziesca e delle possibili richieste – addirittura – di “messa fuori legge” (sono anche i mesi dell’anatema lanciato verso i militanti comunisti dalla Chiesa Cattolica). Il punto forte d’aggancio per la “legittimazione nazionale” del PCI era rappresentato dalla Costituzione. La Costituzione, alla cui stesura i parlamentari comunisti avevano fornito un fondamentale contributo, costituiva un argine contro la tendenza all’arroccamento settario e l’aspetto probabilmente più vistoso della contraddizione tra la critica della democrazia borghese e l’adesione al sistema politico italiano: era quello il punto vero sul quale si saldava la logica della “doppiezza”. L’esito più importante di quella tormentata stagione fu dunque rappresentato da un’espressione piena di lealismo costituzionale da parte comunista, attraverso il quale si esprimeva un’indubbia radice di integrazione nella democrazia repubblicana: una tappa significativa del processo di acculturazione democratica del PCI, un processo di lungo periodo, come tutti quelli che si verificano nella sfera della cultura collettiva, ma soprattutto un processo tutt’altro che lineare e irreversibile, soggetto a continue oscillazioni e strappi, costantemente esposto alle difficili congiunture della situazione politica interna e internazionale ma dimostratosi saldamente acquisito, come si verificherà nel futuro, in altri complessi frangenti come quelli del ’53 con la “legge truffa” , del ’56 con il verificarsi quasi contemporaneo del XX congresso e dei fatti d’Ungheria, del ’60 con i fatti del luglio e la caduta in piazza del governo Tambroni. Il “partito nuovo” di impronta togliattiana, come aveva superato il frangente del luglio ’48 superò anche quei complessi passaggi dimostrandosi, nella sostanza, pilastro della democrazia repubblicana e, insieme, per milioni di iscritti e di elettori portatore di una prospettiva di cambiamento per il futuro».Come si vede il testo di Astengo, che sull'argomento è uno dei più diffusi sul web, per quanto ben fatto, non approfondisce i rapporti tra PCI e URSS, riconducendo le scelte politiche alla responsabilità totale e convinta di Togliatti e del resto dei dirigenti, ormai chiaramente allineati con l'idea della democrazia costituzionale repubblicana. È una tesi che cozza con la ricostruzione, molto più dettagliata e dialettica, offerta da Solano136:
«Il 14 luglio un evento tanto imprevedibile quanto grave e provocatorio come l’attentato a Togliatti sembrò riaprire prospettive che erano state frettolosamente archiviate; una situazione ingessata, caratterizzata dalla rassegnazione alla sconfitta pareva rovesciarsi nel suo opposto; ancora una volta le masse popolari ed in particolar modo i militanti comunisti sentivano di poter riprendere in mano il proprio futuro, confortati dalle indicazioni che provenivano da Radio Mosca. All’indomani dell’attentato a Togliatti, Radio Mosca in lingua italiana dava apertamente ai propri ascoltatori l’indicazione di trasformare lo sciopero in insurrezione aperta. Le posizioni sovietiche, opposte a quelle del partito, vennero deformate o nascoste, per quanto possibile, ai militanti; tuttavia, nelle regioni italiane dove arrivavano le trasmissioni di Radio Mosca, i meccanismi di controllo della base da parte dell’apparato togliattiano divenivano improvvisamente traballanti. La gravità della situazione veniva sottolineata, in una riunione del Comitato Regionale piemontese del partito, dalle parole del segretario regionale che affermava: “Radio Mosca ci ha dato un orientamento molto avanzato che creava una situazione insurrezionale o quasi tra i compagni”137. I dirigenti togliattiani invece di intercettare la volontà politica della base si assunsero in questa situazione il compito di sterilizzarla e sostennero che “una certa leggerezza è stata aver interpretato la trasmissione di Radio Mosca come una specie di direttiva. Una simile direttiva non poteva che giungere dal Comitato Centrale del nostro partito”138. Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario provinciale della federazione di Asti criticava i comunisti sovietici e minacciava, con un linguaggio rancoroso, la base partigiana alla quale non era mai stato perdonato il ritorno sui monti del 1946: “Si è fatto al partito anche un’altra critica, ben più grave. Si è pensato e si è anche detto che si sarebbe dovuto lanciare la parola d’ordine dell’insurrezione e […] che tale era l’orientamento venutoci da Radio Mosca. Il PCB [Partito Comunista (Bolscevico) dell’URSS] non può dare un ordine a noi, dimenticando che il nostro partito ha un suo Comitato Centrale e una sua direzione e che sono questi gli organi che guidano la nostra azione in qualsiasi momento”. Nella prosecuzione del suo intervento Villa criticava “i compagni responsabili che hanno avuto il torto di pubblicare sul Bollettino della Camera del Lavoro di Torino la famosa trasmissione di Radio Mosca” e concludeva sentenziando che “il problema dei partigiani va risolto una volta per sempre. I partigiani devono ricordare che la guida è una: il Partito”139.
Il tentativo di neutralizzare possibili sviluppi insurrezionali della base non convinceva per nulla i quadri intermedi del partito; un dirigente della federazione di Asti, per nulla irretito dai tentativi del vertice del partito di minimizzare le posizioni sovietiche “circa la trasmissione di Radio Mosca fa rilevare che il testo è stato trasmesso anche in russo e in polacco, cosa per cui non si può sottovalutare, come si è fatto, la serietà della trasmissione”140. In un’infuocata riunione del Comitato Regionale del Piemonte, Leone, una figura di notevole prestigio nel partito in quella regione, dopo aver sottolineato che gli intenti rivoluzionari della base erano “confortati dalle comunicazioni di Radio Mosca”, affermava che la preoccupazione dei dirigenti del partito “è stata piuttosto la preoccupazione di restare sul terreno legalitario. Questa preoccupazione legalitaria, che un tempo abbiamo sempre giustificato, è stata condannata dall’Ufficio d’Informazione. Tutti i rimproveri dicono questo. Ancora una volta siamo stati chiamati a giustificarci di fronte alle masse non per aver fatto troppo, ma per non aver fatto. Tutti i rimproveri dicono questo. E questo significa diminuzione del prestigio del partito. Non è giusto dire che usciamo rafforzati da questi avvenimenti. Il rimprovero viene perché non abbiamo lottato”141. Se da un lato il gruppo dirigente del PCI si impegnò per neutralizzare gli effetti delle indicazioni dei comunisti sovietici, dall’altro subì lo sciopero seguito all’attentato a Togliatti. Si trattava di una mobilitazione nata all’interno delle cellule delle fabbriche, tra le masse deluse dall’essere state inglobate in una repubblica che riaffermava i contenuti di classe sui quali aveva prosperato il fascismo: “Nella storia del movimento operaio italiano non c’è mai stato uno sciopero generale, così spontaneo, così compatto, così esteso come quello del 14-16 luglio. […] Occorre soprattutto tener conto che lo sciopero generale del 14-16 luglio non fu 'preparato', non fu preceduto da alcun lavoro di organizzazione”142.

In questo quadro i dirigenti del PCI, cercarono di ridurre lo sciopero di Luglio ad una pacata dimostrazione del fatto che “la 'maggioranza' carpita dalla Democrazia Cristiana il 18 Aprile non rispecchia la volontà del paese”143. In realtà non possono esservi dubbi sul fatto che il movimento di lotta ebbe tutti gli aspetti propri di una vera e propria insurrezione: dalle modalità di svolgimento (blocchi stradali, attacchi a prefetture, questure, caserme, telefoni, blocchi stradali, presidio in armi delle fabbriche) alla determinazione con cui non solo la base, ma anche i quadri intermedi del PCI, in gran parte composti da operai ed ex partigiani, si mobilitarono in quei giorni. In quelle lotte, oltre lo sdegno per l’attentato al segretario del PCI, c’era la rabbia per un triennio di sconfitte ed umiliazioni ed insieme la volontà di invertire il corso reazionario della storia degli anni del dopoguerra; in quei giorni rivoluzione e socialismo sembravano diventare realtà e la liberazione pareva riacquistare un significato di emancipazione che era stato troppo presto accantonato. È paradigmatico dello stato d’animo della classe operaia in quei giorni quanto ha scritto Salvatore Vento a proposito della coscienza di classe dei lavoratori comunisti a Milano: “Gli operai di Milano che scesero in piazza 'senza finire neanche di mangiare', che misero in fuga le autoblinde della polizia alla Motta e alla Bezzi, che bruciarono i giornali clericali, Il Popolo e L’Italia (perché furono gli unici giornali che uscirono durante lo sciopero), che si diressero con rabbia alla CdL per imporre ai dirigenti di continuare lo sciopero, erano certamente convinti che bisognava farla finita con le provocazioni fasciste, con la repressione poliziesca di Scelba, con i tentativi padronali dei licenziamenti, insomma erano convinti che il 14, 15 e il 16 Luglio si stava iniziando a lottare per cambiare qualcosa”144.
“Fin dai primi momenti del movimento - scriveva Novella, segretario regionale della Lombardia - è apparsa chiara una cosa: le masse lavoratrici aderendo allo sciopero non consideravano l’astensione dal lavoro, sia pure totale e generale, un mezzo sufficiente per dare forza alla loro protesta e per ottenere il raggiungimento di certi obiettivi. Così non sono apparsi sufficienti neppure i comizi e le altre abituali manifestazioni di piazza. […] Questo orientamento era penetrato largamente anche in quella parte di masse e compagni che davano allo sciopero una erronea interpretazione oltranzista ed insurrezionalista. […] Abbiamo avuto così un po’ ovunque delle irruzioni nelle sedi dei partiti governativi reazionari e fascisti. […] Abbiamo avuto inoltre la quasi generale occupazione delle fabbriche […] alla Motta e alla Bezzi di Milano; […] gli operai di queste fabbriche, aiutati da operai di altre fabbriche, hanno disarmato una ventina di agenti della forza pubblica”145. Un po’ ovunque la mobilitazione delle masse assunse caratteristiche insurrezionali, uscendo ampiamente dagli schemi delineati dalla direziona nazionale. La protesta misurata e controllata venne sostituita con l’intensificazione della lotta di classe e la manifestazione di forme di giustizia partigiana. A Busto, nei dintorni di Varese, “i dimostranti si recarono davanti al carcere mandamentale e chiesero la scarcerazione di alcuni partigiani, già condannati per detenzione di armi; la richiesta si tramutò ben presto in assalto al carcere. Quando l’assalto era in atto, l’autorità locale decise di scarcerare due partigiani già arrestati o condannati. Un nuovo tentativo di assalto al carcere si ebbe all’indomani ad opera di partigiani e manifestanti di paesi vicini a Busto, i quali reclamavano il rilascio di altri tre detenuti non liberati il giorno prima. Questo secondo assalto assunse un carattere più violento del giorno prima. Alcune guardie di finanza e alcuni soldati di guardia al carcere vennero disarmati e i dimostranti, servendosi delle armi strappate presero a sparare contro il carcere; dalle mura si rispose. Vi furono tre soldati feriti. A conclusione, l’autorità locale scarcerò anche gli altri tre detenuti. Queste agitazioni e azioni di forza non furono dirette o controllate dal partito; però elementi di quadro, di loro iniziativa, di fatto ne assunsero il commando”146. A Udine, in una relazione della federazione si scriveva che erano “numerosi gli operai, i braccianti ed i compagni di partito che pensano all’insurrezione. Nella Bassa Friulana ci segnalano che vengono approntati dalle masse parecchi blocchi stradali e dobbiamo intervenire immediatamente perché in alcuni centri i partigiani tendevano a portare non solo il fazzoletto ma anche la divisa con tutti gli accessori”147. A Como traspariva tutta la delusione per la conclusione dello sciopero: “I compagni […] dicono che le masse volevano risolvere e dato che lo sciopero è terminato senza una vera soluzione di fatto, benché abbia in sé una grande vittoria politica, sia stato un cedimento, un elemento di debolezza, che ha scoraggiato i compagni e come tale ne imputano la responsabilità alla direzione del Partito”148. Atteggiamenti analoghi emergevano a Padova: le aspettative della base erano rivoluzionarie “invece giunse l’ordine di cessazione dello sciopero, accolto con malumore da tutti i compagni, da alcuni addirittura con indignazione”149. A Mantova si esprimeva in tutta la sua drammaticità la contrapposizione radicale, all’interno della base, tra insurrezione e rassegnazione: “vi sono dei nostri compagni che dicono: o si fa l’insurrezione o non c’è più nulla da fare”150. Nelle sezioni di Milano la linea del partito veniva criticata perché minimalista ed inadeguata rispetto alle potenzialità di lotta espresse dalla classe operaia: “Nelle officine si sono rivelati dei lavoratori più audaci e più capaci dei nostri compagni stessi […] la parola d’ordine di difendere le fabbriche viene criticata perché non è una parola d’ordine insurrezionale […] in alcune sezioni sono fatte accuse violente a membri delle federazione e anche della direzione del partito”151. Le masse erano deluse ed irritate per la fine improvvisa e rapida dello sciopero; la speranza della base comunista, degli ex partigiani e delle avanguardie operaie di riprendere in mano il proprio destino si era dissolta in poche ore, tra il pomeriggio del 14 luglio e la mattinata del 16. Mario Montagnana, invitato dal Comitato Centrale alla federazione di Torino, doveva ammettere “l’esistenza ancor oggi in seno al partito di uno strato […] di compagni i quali continuano a criticare non solo alcuni aspetti marginali della direzione del movimento […] ma la 'linea' stessa di questa direzione alla quale essi contrappongono una loro linea 'estremista', in contrasto con la situazione obiettiva. Si tratta (a parte pochissimi elementi che cercano di fare opera di disgregazione) di elementi onesti e combattivi, i quali però si illudono che barricate e mitra possano risolvere da soli, e in qualsiasi momento, tutti i problemi delle masse lavoratrici”152.
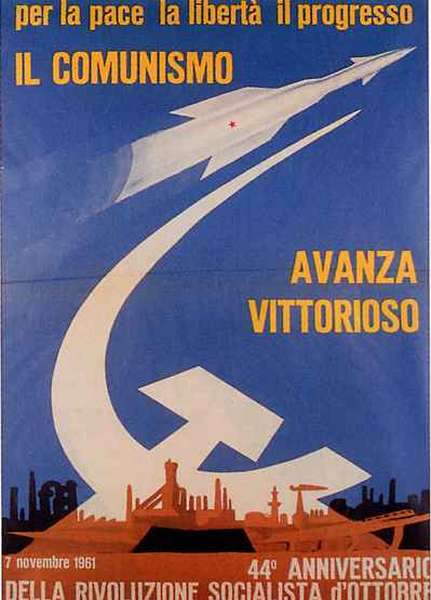
Al di là dei consueti luoghi comuni sull’estremismo, i dirigenti del PCI facevano ricorso alla formula delle “condizioni oggettive” che rappresentava l’immagine verbale della staticità della linea politica partito; la sua apparente concretezza diventava la base teorica per giustificare la sostanziale accettazione del sistema capitalistico da parte del gruppo dirigente togliattiano. Le relazioni inviate dalle sezioni torinesi alla Commissione di Organizzazione della federazione, rispecchiavano il malessere e la sfiducia diffusi tra la base. Nella V sezione “la chiusura dello sciopero è stata per la maggior parte dei compagni una mazzata sulla testa”153. Nella XIV sezione si rilevava che la cessazione dello sciopero era “poco compresa dai compagni, specie dai giovani, che numerosi erano stati in permanenza nei locali della sezione, convinti (anche dalle parole di qualche dirigente) che lo sciopero dovesse protrarsi o sfociare: o nelle commissioni del governo o in un moto insurrezionale”154. Ed ancora: “l’annuncio della cessazione dello sciopero [annotava la relazione della XVIII sezione] è giunto come un fulmine a ciel sereno (per i compagni e quella parte della popolazione sul nostro terreno). Vi fu anche fra di noi una violenta ostilità a questa decisione […] e non fu facile portarli sul ragionamento politico. Dicevano questi compagni che […] non ci si doveva limitare ad una dimostrazione di protesta, anche energica, ma limitata nel tempo e negli obiettivi. In sostanza non creare l’illusione che si era creata per ritrovarci in una situazione di insoddisfazione e di demoralizzazione”155. A Genova, dove le provocazioni poliziesche avevano causato tre morti e sei feriti, le masse reagirono con blocchi stradali e con il sequestro di diverse autoblinde della polizia; di fronte alla determinazione dei militanti il segretario Pessi doveva ammettere, nella sua relazione, che l’atteggiamento passivo dei dirigenti nazionali non era pienamente condiviso dalla base: “qualche compagno […] nel corso dello sciopero e anche dopo ha dichiarato che forse esistevano le condizioni per fare l’insurrezione”. Poi, riproponendo la consueta argomentazione dell’assenza delle “condizioni oggettive” per un’insurrezione, aggiungeva: “Voi sapete che se vi fossero state, il partito non avrebbe esitato”156. La linea dei dirigenti nazionali che auspicava una “manifestazione senza sconfinamenti” non trovava adesioni neanche a Bologna: “compagni che ricoprono funzioni di responsabilità [rilevava Colombi] impartivano direttive non sempre coerenti con la linea politica del partito. […] Bisogna che tutti i compagni, specialmente quelli che occupano posti di responsabilità, si rendano conto che l’iniziativa politica personale ha dei limiti che sono posti dalla linea politica del partito e che nessuno ha il diritto di compromettere questa linea, creando situazioni nuove. […] La cessazione dello sciopero senza aver ottenuto le dimissioni del governo costituiva secondo loro una capitolazione. Essi affermavano che le masse non avrebbero capito e che in ogni caso vi sarebbero state manifestazioni di malcontento con conseguente sfiducia e demoralizzazione”157. L’opposizione interna veniva liquidata attraverso il massiccio ricorso all’espulsione dal partito dei dissidenti: in questo senso è significativa la documentazione pubblicata nel Bollettino settimanale di direttive per le sezioni dei militanti espulsi dal partito. Tutti i numeri del secondo semestre del 1948 del Bollettino interno contengono l’elencazione minuziosa dei numerosi quadri intermedi e militanti di base espulsi perché in netto dissenso con la passività della linea del vertice del partito. Non mancavano i militanti che abbandonavano spontaneamente il partito: nella federazione di Varese “non sono pochi i compagni delusi che, essendosi atteso di marciare molto avanti, accusano la sensazione di dover ripiegare o addirittura di dover capitolare. In una sezione dodici compagni avrebbero restituito la tessera, in qualche altra parte si segnalano manifestazioni di scontento”158. Estremamente indicative dell’orientamento del partito erano le critiche rivolte ai dirigenti locali che non avevano accettato il ruolo di esecutori passivi delle direttive moderate del partito: “Era indispensabile mettere a tacere i provocatori e le teste calde; […] i compagni dirigenti non hanno ripreso energicamente, nel corso e dopo il movimento, le posizioni settarie dei compagni […]. Non si è fatto nulla […] per rassicurare coloro che avevano paura e gli 'amanti del quieto vivere' che non avevano nulla da temere. […] Non si è fatto nulla o quasi per fraternizzare con i carabinieri e con le forze di polizia”159.
Gli umori della borghesia e la fratellanza con i pretoriani di Scelba che sparavano sui dimostranti e li travolgevano con i loro automezzi erano le maggiori preoccupazioni dell’apparato togliattiano. Ben altri erano gli obiettivi per cui le masse popolari scesero in piazza nelle giornate del luglio 1948; la radicalità rivoluzionaria profondamente diffusa nella mobilitazione popolare seguita all’attentato a Togliatti cozzava con la stridente sordità di un PCI che subiva un movimento di lotta che non aveva promosso, ma che voleva controllare ed incanalare nell’alveo delle rituali ed innocue sfilate “in difesa della democrazia e della pace”160. La conclusione dello sciopero del luglio 1948 segnò il definitivo declino della tensione rivoluzionaria della base del partito, spiazzata per l’ennesima volta dall’immobilismo del gruppo dirigente. La sfiducia e la demoralizzazione, che si diffondevano tra i militanti più coscienti, facilitavano il loro progressivo scivolamento verso forme di “praticismo” e di definitivo svuotamento dell’essenza rivoluzionaria. La scelta dei dirigenti del PCI di contenere entro limiti “legali” la mobilitazione seguita all’attentato a Togliatti non produsse soltanto riflessi interni al partito ma segnò l’inizio di decenni di rassegnazione e di sconfitta per le masse popolari. Alla conclusione dello sciopero seguirono i licenziamenti delle avanguardie operaie, la repressione poliziesca161 e, dulcis in fundo, la fine della stagione dell’unità sindacale, iniziata con il “patto di Roma” e conclusa con la nascita del sindacato cattolico; la passività del PCI sul piano sindacale, aveva potuto rinviare di qualche mese, ma non certo impedire la rottura sindacale. “Noi rivendichiamo al pluralità sindacale [scriveva la Civiltà Cattolica] il pericolo sarebbe grave per gli operai cattolici di essere uniti con i socialisti e i comunisti; […] in questo periodico noi ci intrattenemmo sul problema che sollevava questo avvenimento (unità sindacale) e dopo aver fatto le nostre riserve sull’organizzazione unitaria, formatasi soprattutto per opera dell’on. Grandi e del Buozzi, ci dichiarammo per la prova dell’unità sindacale. Poiché (scrivemmo allora) la pace metterà innanzi i formidabili problemi della smobilitazione industriale […] si potrebbe tollerare provvisoriamente un’unità di lavoratori in un solo organismo, con le relative clausole del rispetto ai principi sociali e religiosi”162. L’amarezza per il corso reazionario della storia del nostro paese, inscritto nella scelta rinunciataria della direzione del partito, traspariva dalle parole di un dirigente locale che, sul finire del 1948, avrà modo di affermare: “nel 1945 esisteva in Italia una situazione pre-rivoluzionaria, mentre oggi qui è clericale”163. Dall’affermazione di quest’epoca di glaciazione conservatrice, costruita lungo l’asse Vaticano-padronato-imperialismo americano, la direzione togliattiana porta sulle proprie spalle un’enorme, indelebile, responsabilità. È la storia di una sconfitta drammatica che ha condizionato irrimediabilmente il destino delle classi sfruttate e che ci accompagna fino ai nostri giorni».La conclusione di Solano è quindi radicalmente diversa da Astengo: la reazione sedata della base avviene non per volontà del COMINFORM, quanto per decisione del gruppo dirigente italiano, nonostante non siano mancati aspri contrasti interni nello stesso per la scelta di mantenersi fedeli alla via del riformismo. Era possibile una Rivoluzione in un simile frangente? Ha detto Secchia164 di fronte al Comitato centrale riunito a Roma il 15 luglio '48:
«Le forze insurrezionali sono concentrate nelle grandi città del Nord, ma la campagna anche al Nord non è sicura, le comunicazioni fra città e città sarebbero incerte; i compagni della base dicono: “Abbiamo in mano le fabbriche, abbiamo in mano la città”. I compagni riflettano: per ora né la polizia né l'esercito sono intervenuti, se lo faranno disporranno di cannoni e di carri armati contro cui non si potrà resistere. […] L'URSS non può rischiare una guerra con l'America che ha la bomba atomica, e l'America certamente interverrebbe: primo perché ha da noi le sue basi, secondo perché non le mancherebbe una giustificazione politica. Non dimenticate, compagni, che siamo a soli due mesi e mezzo dalle elezioni che hanno dato una maggioranza assoluta al governo. Ma anche senza l'intervento americano l'insurrezione sarebbe destinata al fallimento: l'Italia è già praticamente spezzata in due, il governo controlla con le sue forze le comunicazioni fra Firenze e Bologna e l'Italia del Sud non si è mossa; ci sono città come Napoli, come Bari, dove non si è riusciti neppure a fare un comizio».A distanza di vent'anni Secchia avrebbe confermato il suo giudizio:
«Si è detto che io avrei cercato di dare un impulso insurrezionale allo sciopero. Storie! C'erano tre centri, tre grandi città su cui si poteva contare sicuramente: Torino, Venezia e Genova, il resto rimaneva in incerto equilibrio o saldamente presidiato dal governo. Sì, lo so, ancora oggi dei compagni mi rimproverano di indecisione, come se non ci fosse rimasto altro da fare che tendere la mano e cogliere il frutto dello sciopero. La verità è che il momento difficile, lo scontro vero doveva ancora incominciare. La battaglia grossa non ci fu, ecco perché i compagni della nostalgia pensano che avessimo già vinto».L'opinione di Togliatti è assai più caustica:
«Certo, l'attacco insurrezionale – e la certa sconfitta – nel 1946 o nel 1948 avrebbero fatto piacere a molti. Niente burocratizzazione, in quel caso! Tutti i “quadri rivoluzionari” a scuola di strategia e di tattica nei carceri o nell'esilio! E gli eroi alla Clara Bovero [una socialista che ha polemizzato sulla burocratizzazione del PCI], rimasti in libertà, ci avrebbero senza dubbio scritto su qualche bel compitino!»165Probabilmente il momento propizio era d'altronde ormai passato.
Diamo spazio in tal senso alla critica fatta a Togliatti da Amedeo Curatoli166:
«Un ammiraglio Usa (Carney) in un’intervista all’Europeo (nel 1952) disse: “Nel 1948 quando pareva che le elezioni italiane potessero terminare in una guerra civile... a Washington eravamo preoccupati del fatto che i vostri carabinieri e l’esercito mancavano di armi leggere e che forse avrebbero avuto difficoltà a sedare una rivolta... Nessuno si assumeva la responsabilità di prendere una decisione... La decisione la presi io. Caricai una nave da trasporto di armi leggere e diedi ordine di partire per il Mediterraneo. Il capitano doveva incrociare la costa italiana in attesa di ordini... La nave non si avvicinò mai alla costa italiana e tornò negli Stati uniti con il carico intatto perché per fortuna non vi fu bisogno di sedare nessuna rivoluzione”. Ogni rivoluzione che avviene nel mondo ha a che fare con gli Stati Uniti d’America, principale forza controrivoluzionaria, nemico numero uno dei popoli che abitano il nostro pianeta. Quindi, dovunque si può dire, senza tema di sbagliarsi: “c’erano gli americani”. In Cina non navigava, al largo delle coste, un cargo di armi leggere americane a dare man forte alla guerra civile anticomunista di Chiang Kai-shek, ma c’erano aeroporti militari Usa in territorio cinese e basi navali e navi da guerra Usa fin dentro allo Yang Tse Kiang, c’erano armi, danaro, aerei, istruttori militari Usa, bombe al napalm e chimiche, carri armati e artiglieria pesante, assistenza tecnologica di grande livello per tenere in efficienza le linee ferroviarie e costruirne di nuove per trasportare le truppe del Kuomintang all’assalto dell’Esercito comunista in ogni angolo del vastissimo paese, c’erano trattati di asservimento nazionale che i reazionari cinesi firmarono con gli Usa svendendo gli interessi della Cina e la sua sovranità nazionale, neanche i crimini di stupro e maltrattamenti e uccisioni di cinesi da parte dei militari Usa potevano essere giudicati dalla magistratura del Kuomintang. […] Ma alla fine gli americani e Chiang Kai shek furono gettati a mare e si andarono a rifugiare a Taiwan. E in Vietnam? […] “C’erano gli americani”... Gli americani ci saranno sempre finché l’imperialismo Usa non verrà distrutto, quello che hanno fatto in Cina, in Corea, in Vietnam e ieri in Iraq, lo stanno facendo oggi in Afghanistan, Pakistan, Libia, Siria e Ucraina. Per non parlare degli innumerevoli crimini commessi in America Latina (il più atroce di tutti: in Cile). Quindi dire, come abbiamo sentito migliaia di volte “in Italia c’erano gli americani” è soltanto un modo controrivoluzionario per accettare a cuor sereno il tradimento della Resistenza e rassegnarci, giocoforza, alla fogna di oggi in cui siamo immersi fino al collo. […] Queste decine di migliaia di giovani divenuti partigiani diedero vita ad un’autentica iniziativa storica irripetibile, che avrebbe potuto e dovuto necessariamente determinare una svolta politica radicalmente nuova. Un partito comunista avrebbe potuto e dovuto convogliare questa forza verso il regolamento dei conti finale con i responsabili della catastrofe in cui fu gettata l’Italia. La linea illusionista di Togliatti, quella che lui tirò fuori dal cilindro (e si vantava di esserne il geniale teorico!) cioè “la via diversa di accostamento al socialismo”, che serviva solo ad illudere la classe operaia, appare ancora più grave se si pensa che proprio in quella fase cruciale di passaggio dal fascismo a nuovi assetti statali, in Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e Albania si stava lottando non solo per distruggere regimi quisling ma per continuare una lotta ancora più aspra per giungere (e alla fine si giunse!) al socialismo. “Da noi non esistevano le condizioni” hanno sempre detto i togliattiani, disarmando ideologicamente la classe operaia e le masse popolari. Ai vili e ai pedanti che di fronte a fenomeni rivoluzionari di massa, anche imprevedibili e imprevisti, ma pur sempre autentici movimenti rivoluzionari di portata storica, a questi pedanti che si tiravano indietro accampando la mancanza di condizioni per la vittoria Marx diceva che “sarebbe assai comodo fare la storia universale se si accettasse battaglia soltanto a condizione di un esito infallibilmente favorevole” (citato in Lenin, Prefazione alle lettere a Kugelmann). Insomma: la Resistenza è stata l’occasione storica per creare il socialismo in Italia».

134. Citato in G. Bocca, Palmiro Togliatti, cit., p. 471.
135. F. Astengo, Sessantacinque anni fa: l'attentato a Togliatti, Il Pane e le Rose, 14 luglio 2013.
136. S. Solano, La svolta borghese di Togliatti, cit., cap. L'attentato a Togliatti: Radio Mosca e le mobilitazioni popolari, pp. 149-156.
137. Riunione del Comitato Regionale piemontese del 17/7/1948, intervento di Grassi, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Piemonte 1948.
138. Intervento di Negarville alla riunione del Comitato Regionale piemontese del 28 luglio, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Piemonte 1948.
139. Intervento del segretario di provincia Villa alla riunione del Comitato Federale di Asti del 2/8/1948, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Piemonte 1948.
140. Ibidem, intervento di Bausano.
141. Ibidem, intervento di Leone.
142. P. Secchia, Esperienze di un grande sciopero, in Quaderno dell’attivista, agosto 1948, p. 3.
143. Ibidem.
144. F. Levi, P. Rugafiori, S. Vento, Il triangolo industriale, Feltrinelli, Milano, 1974, p. 206.
145. Cfr. A. Novella, Come si è svolto lo sciopero, in Quaderno dell’attivista, agosto 1948, p. 7.
146. Relazione sullo sciopero generale dei gg. 14/16 luglio 1948, Federazione di Varese, significativamente intitolata Aspetti violenti dello sciopero, p. 2, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Lombardia 1948.
147. Relazione sullo sciopero generale del 14-15-16-17, Federazione di Udine, p. 4, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Friuli, 1948.
148. Verbale della Riunione del Comitato Federale di Como del 17/7/1948, intervento di Mazza, p. 5, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Lombardia 1948.
149. Si veda la Relazione alla direzione del PCI della segreteria della federazione di Padova, a firma del segretario provinciale, Giuseppe Gaddi, pp. 3-4, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Veneto 1948.
150. Verbale della Riunione del Comitato Federale di Mantova del 13 Ottobre 1948, p. 2, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Lombardia 1948.
151. Verbale della Riunione del Comitato Federale di Milano del 21/7/1948, intervento di Vergani, p. 7, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Lombardia 1948.
152. Cfr. M. Montagnana, Come si è svolto lo sciopero, in Quaderno dell’attivista, agosto 1948, p. 12.
153. Relazione sullo sciopero generale, indirizzata dalla V sezione alla Commissione di Organizzazione, datata 9/8/1948, p. 2, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Piemonte 1948.
154. Relazione sullo sciopero generale, redatta dalla XIV sezione, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Piemonte 1948.
155. Relazione sullo sciopero generale, scritta a cura dalla XVIII sezione, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Piemonte 1948.
156. Relazione del segretario della federazione di Genova, Pessi, al Comitato Federale del 30/7/1948, p. 5, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Liguria 1948. Un’ampia documentazione degli orientamenti rivoluzionari della base del partito genovese è contenuta in F. Levi, P. Rugafiori, S. Vento, cit., pp. 94-98.
157. Relazione del segretario della federazione di Genova, Pessi, al Comitato Federale del 30/7/1948, p. 5, in cit.
158. Relazione sullo sciopero generale della federazione di Varese, p. 5, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Liguria 1948.
159. Cfr. F. Cavatassi, Come si è svolto lo sciopero, in Quaderno dell’attivista, agosto 1948, pp. 12-13.
160. Si veda P. Secchia, Esperienze di un grande sciopero, in cit.
161. Al riguardo Candeloro ha scritto che: «più di 92.000 lavoratori, di cui 73.000 comunisti, furono arrestati e rinviati a giudizio: di essi 19.306, tra i quali 15.429 comunisti, furono condannati a pene varie. Inoltre tra l’Estate del 1948 e la prima metà del 1950 ben 62 lavoratori, di cui 48 comunisti, furono uccisi dalla forza pubblica oppure da squadre di agrari o di fascisti; i feriti furono 3.126, dei quali 2.367 comunisti» (G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna. La fondazione della repubblica e la ricostruzione. Considerazioni finali (1945-1950), Feltrinelli, Milano, 1986, vol. XI, p. 192). Sullo stesso argomento di vedano Delitti dell’anticomunismo. La repressione dopo il 14 luglio (articolo redazionale), in Rinascita, n° 8-9, agosto-settembre 1954, pp. 540-44 e R. Del Carria, Proletari senza rivoluzione, Ed. Savelli, Roma, 1975, vol. IV, p. 212.
162. Si veda sull’argomento l’articolo Azione Cattolica e ACLI lunga mano della scissione, in Bollettino del Lavoro, 24/8/1948, che cita il brano della Civiltà Cattolica riportato nel testo.
163. Verbale della riunione del Comitato Federale di Trento del 4/12/1948, p. 4, in Istituto Gramsci di Roma, Archivio del Partito Comunista Italiano, Trentino 1948.
164. G. Bocca, Palmiro Togliatti, cit., pp. 469-470.
165. Ivi, pp. 474-475.
166. A. Curatoli, Contro il revisionista Togliatti, cit., pp. 34-37.